|
BREVE
STORIA D'ITALIA
IL
PRIMO CENTROSINISTRA
Negli
anni del miracolo economico si erano aggravati gli squilibri sociali,
nel senso che per molte fasce di popolazione nulla era cambiato
rispetto ai decenni precedenti, mentre altri settori della società
avevano vissuto un netto avanzamento delle proprie condizioni
di lavoro e di vita. Si è già detto di come l’espansione
industriale avesse spinto milioni di persone ad abbandonare le
aree agricole di pianura e di montagna, ma non erano solo i centri
urbani ad essere interessati al fenomeno immigratorio: intorno
alle grandi città la campagna lasciò posto a un’intensa
edificazione e vicino alle fabbriche i piccoli paesi diventarono
ben presto nuclei abitativi ad alta densità, secondo un
tipico processo delle società industrializzate in base
al quale la città propriamente detta viene progressivamente
a trasformarsi in una vasta area metropolitana,
dove non vi è soluzione di continuità fra centro
storico, periferia e località minori.
  

Ciò comportò radicali mutamenti nell’organizzazione
del tessuto urbano: ogni giorno enormi quantità di persone
erano costrette a spostarsi dall’abitazione al lavoro
e viceversa, e i problemi connessi (carenza dei mezzi pubblici,
traffico, inquinamento, tempi di vita che si modificavano,
viabilità
insufficiente, ecc.) assunsero dimensioni drammatiche: per anni,
tuttavia, questi aspetti restarono del tutto estranei all’impegno
dell’amministrazione pubblica, la quale semplicemente
lasciò
che il fenomeno si sviluppasse in modo spontaneo, senza quegli
interventi, anche di prospettiva (piani urbanistici, aree verdi,
potenziamento dei trasporti collettivi), che avrebbero potuto
disegnare una crescita urbana se non proprio a misura d’uomo
almeno con caratteristiche minimamente razionali.
Il cambiamento riguardò in profondità anche i comportamenti
individuali, i modelli culturali, gli stili
di vita. La prima e principale novità era dovuta al
considerevole aumento di reddito da parte
di milioni di persone: molte abitazioni venivano trasformate
e rese più confortevoli (nel 1951
solo il 7,4% delle case italiane possedeva la combinazione di
elettricità, acqua potabile, servizi igienici interni),  ma
la stessa introduzione di bagni moderni e di elettrodomestici mise
in moto un vasto meccanismo, permanente, di crescita dei
consumi, con l’acquisto di prodotti per la casa, per
l’igiene
personale, per l’alimentazione, che proprio in quegli anni
diventarono i soggetti più significativi del mercato
pubblicitario. E, naturalmente, arrivò la televisione. ma
la stessa introduzione di bagni moderni e di elettrodomestici mise
in moto un vasto meccanismo, permanente, di crescita dei
consumi, con l’acquisto di prodotti per la casa, per
l’igiene
personale, per l’alimentazione, che proprio in quegli anni
diventarono i soggetti più significativi del mercato
pubblicitario. E, naturalmente, arrivò la televisione.
Un
altro capitolo fondamentale, sia sotto il profilo economico
sia sotto quello sociologico, furono i consumi legati al tempo
libero e in genere quelli di carattere voluttuario:
l’automobile,
innanzi tutto, gli scooter, il cinema, i dischi, i cosmetici,
gli alcolici, le sale da ballo, e così via. È noto
che i libri rimasero e rimangono una voce del tutto marginale:
molte sono le sconfortanti statistiche a riguardo, che ci pongono
agli ultimissimi posti nella graduatoria dei lettori europei,
e basterà aggiungere che circa l’80% degli italiani
non legge nemmeno un libro all’anno. E, a cavallo fra
i consumi considerati primari e quelli superflui, non si devono
dimenticare due voci che oltre a tutto acquisteranno sempre
più
rilevanza nella bilancia commerciale con l’estero: l’abbigliamento
e il turismo. Vestirsi dignitosamente smetteva di essere un
privilegio per pochi (ed era esattamente così fino a
pochi anni prima), ma una possibilità per (quasi) tutti,
e a ciò si
aggiunse una certa modernizzazione della mentalità che
portò molte persone, specie di età più giovane,
a vedere nell’abito non più un semplice accessorio
funzionale ma un modo di esprimere emozioni, gusti, valori;
anche andare in vacanza era stato poco più che un sogno
per la massa degli italiani, ma una maggior facilità degli
spostamenti, unitamente alle più forti capacità di
spesa e al mutare delle abitudini, trasformò le ferie
in un appuntamento obbligato, pur restando ancora per molto
tempo appannaggio di una minoranza.
 
L’elevazione della scuola dell’obbligo
a 14 anni e la riforma della scuola media, nel
1962 (ma nel decennio 1951-1961 non vi furono modificazioni strutturali
nel livello d’istruzione, se non nella diminuzione degli
analfabeti, dal 13 all’8%, e nell’aumento dei diplomi
di media inferiore dal 6 al 10%; solo nei due decenni successivi
i dati migliorarono sensibilmente: analfabeti al 5 e poi al 3%;
media inf. al 15 e al 24%; media sup. al 7 e al 12%; laurea al
2 e al 3%. Vale la pena notare che nel 1981 il livello d’istruzione
del Sud è abbastanza omogeneo alla media nazionale: unica
eccezione gli analfabeti, 6,4% al Sud e 3,1 al Nord) aprirono
le porte alla scolarizzazione di massa, e anche questo contribuì
non poco - seppur con tutti i limiti che vedremo meglio nel capitolo
dedicato alla cultura - a trasformare il modo di vita degli italiani.
Già, ma le italiane?
Il ventennio di Mussolini aveva celebrato il ruolo della donna:
moglie (fedele, non si discute nemmeno) e madre, o al massimo
sorella, e lo stesso Pirandello (“fascista
per caso” si potrebbe dire, comunque il più grande
scrittore italiano moderno) dovette in qualche modo ridimensionare
la portata del primo vero romanzo femminista della nostra cultura, L’esclusa. Nel dopoguerra Stato e Chiesa accolsero
di buon grado questa consacrazione, né d’altra
parte vi erano condizioni socioeconomiche che favorissero un
massiccio ingresso della donna nel mercato del lavoro: il boom
industriale in alcune zone aveva anche sensibilmente aumentato
la quota di occupazione femminile (nell’ambito impiegatizio,
nel settore tessile-abbigliamento, nel comparto alberghiero),
ma nel complesso il tasso della disoccupazione femminile rimase
assai più
alto che negli altri paesi europei. Esauritisi poi gli effetti
immediati del miracolo economico, furono ovviamente le donne
le prime ad essere espulse dal mercato (la loro disoccupazione
addirittura triplicò fra il 1963 e il 1983), anche perché il
modello culturale proposto in quegli anni stimolava fortemente
la centralità della casalinga che acquista i prodotti
per la casa e bada ai figli: più consumi, meno servizi
sociali, e soprattutto niente grilli per la testa!
E niente politica, ben inteso. Ma questo valeva anche per gli
uomini, soprattutto per quelli che un lavoro ce l’avevano
e che le aziende avevano provveduto a tenere a bada con le minacce
o col paternalismo. Sembrava dunque che dopo la grande ondata
repressiva degli anni ‘50 nelle fabbriche l’ordine
regnasse sovrano, ma come in fisica ad un’azione corrisponde
una reazione uguale e contraria, talvolta anche nella società
accade qualcosa di analogo, che cioè un fenomeno contenga
in sé anche la propria antitesi: furono le stesse forze
capitalistiche che attuarono il boom a colpi (non metaforici)
di bastone ad attivare inconsapevolmente una potente controspinta.
   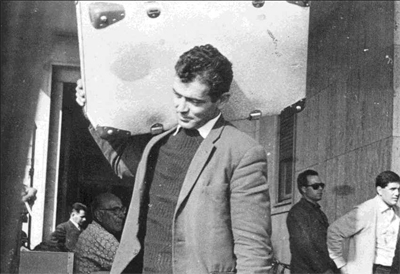
emigrazione_3L’emigrazione al Nord fu particolarmente massiccia in quanto nei centri industriali
vi erano le condizioni perché ciò avvenisse: le
industrie, insomma, avevano bisogno di manodopera e il Sud era
un serbatoio gigantesco e assai poco costoso, e gli immigrati
non furono subiti dai settentrionali, ma richiesti e, almeno in
quanto salariati, graditi. Qualcuno ebbe a dire, non si sa bene
se per razzismo o banale ottusità, che i lavoratori meridionali
sputarono nel piatto in cui mangiavano, e in effetti fu proprio
da loro, e in particolare dai giovani, che partirono i primi segnali
che non tutto sarebbe andato come previsto.
Una delle condizioni strutturali alla base del miracolo economico
fu che la produzione industriale subì importanti e radicali
modificazioni dal punto di vista dell’organizzazione del
lavoro: la fabbricazione o la lavorazione del prodotto tendeva
a non basarsi più sull’attività di precisione,
su compiti che richiedevano in genere un’alta professionalità,
bensì su mansioni ripetitive e ad alta velocità,
tipiche in particolare della catena di montaggio, dove i pezzi
da modificare o da montare scorrono continuamente davanti a un
addetto che manovra una macchina o usa un attrezzo.
Tanta parte della nostra storia recente è scandita dal
miglior cinema italiano:
 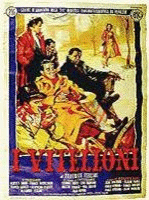  
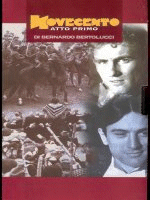 

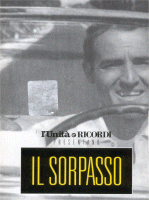  

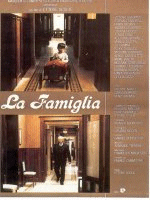 
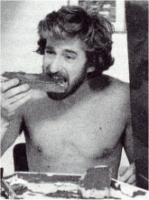

I giovani operai meridionali non si aspettavano certo un lavoro
di tutto riposo, ma nemmeno quell’insopportabile e monotono
ripetersi di gesti sempre uguali, e in più erano carichi
di rabbia per aver dovuto abbandonare la propria terra e la propria
cultura, per essere arrivati in una città spesso ostile
e avara: furono proprio loro a introdurre nelle fabbriche una
nuova carica di combattività e i vecchi operai piemontesi
e lombardi, superata una certa diffidenza iniziale, risposero
con energia.
L’occasione fu, nel 1962, il rinnovo del contratto
dei metalmeccanici, imperniato sulla riduzione dell’orario
settimanale da 44 a 40 ore e sulla diminuzione delle differenze
salariali. Le iniziative di lotta trovarono una buona partecipazione
nelle fabbriche, ma era proprio l’azienda simbolo, e più
grande, che restava totalmente assente: durante la prima giornata
di sciopero, dei quasi centomila lavoratori della Fiat non c’era
in piazza nessuno. La Stampa (di proprietà degli Agnelli) lodò il loro “senso di
responsabilità”, ma forse questo paternalismo fu
un’umiliazione gratuita ed eccessiva, perché al secondo
sciopero i più sindacalizzati presero coraggio e si unirono
al corteo sindacale, e al terzo furono in oltre 60.000 a restare
fuori dai cancelli. Di fronte a questa pericolosa e inaspettata
inversione di tendenza, la direzione Fiat tentò di dividere
il fronte dei lavoratori concludendo un accordo separato con la
UIL e il Sida, il sindacato giallo a cui si è già
accennato, e, al fine di rendere ancora più efficace la
mossa, per la firma scelse proprio il giorno in cui la FIOM-CGIL
e la FIM-CISL avevano proclamato uno sciopero di tutti metalmeccanici
torinesi: migliaia di operai si riunirono a protestare in piazza
Statuto, di fronte alla sede della UIL, e ne nacquero
violenti scontri con la polizia. Al di là della gravità
dell’episodio, resta il fatto che da quel rinnovo contrattuale
riprese, con alterne vicende, un movimento di lotta che negli
anni a venire avrà un peso determinante in tutta la vicenda
italiana.
 Se
il boom fu il tratto distintivo di quegli anni, nel mondo politico
erano in corso sommovimenti in apparenza assai meno clamorosi,
ma che poi ebbero un’evoluzione di grandissimo rilievo. Se
il boom fu il tratto distintivo di quegli anni, nel mondo politico
erano in corso sommovimenti in apparenza assai meno clamorosi,
ma che poi ebbero un’evoluzione di grandissimo rilievo.
Dopo l’abbandono di De Gasperi, i governi che si susseguirono
non riuscirono mai a trovare quella stabilità che pure
sarebbe stata necessaria in una fase di così profonde trasformazioni
sociali, anche perché all’interno della DC vi era
un’accesa controversia sulla prospettiva politica: si poteva
proseguire, come sosteneva Scelba, nella linea centrista che aveva
permesso di battere le sinistre ma che manifestava chiari segni
di inadeguatezza rispetto al mutare degli eventi, oppure bisognava
tentare l’apertura a sinistra, puntando a un’alleanza
con l’ala meno radicale e isolando i comunisti? Questa era
la tesi dell’uomo di punta del partito, Amintore Fanfani,
che per un certo periodo sommò la carica di Presidente
del Consiglio a quella di Segretario DC; ma, soprattutto nei partiti
moderati, non sempre un dibattito interno si risolve secondo precise
discriminanti ideali e prevalgono piuttosto i compromessi di vertice,
le intese fra gruppi di potere. E così, se ebbe la meglio
la proposta di Fanfani, non fu quest’ultimo a gestirla,
bensì la coalizione dei suoi avversari: la sinistra guidata
da Aldo Moro, la destra di Andreotti e la nuova grande corrente
promossa da molti ex amici di Fanfani, i dorotei
(capofila Rumor e Colombo),
la cui denominazione deriva dal fatto che la loro prima riunione
si tenne nel convento di Santa Dorotea.
Per corrente s’intende un gruppo che si organizza,
all’interno di un partito o di un sindacato, per portare
avanti un determinato progetto politico, in contrapposizione ad
altri gruppi della medesima organizzazione. Nella sinistra comunista,
formatasi sull’idea di partito estremamente compatto concepita
da Lenin, tale tipo di articolazione interna non fu mai tollerata,
e chi in vario modo si muoveva in questo senso veniva espulso
per “frazionismo”. In opposizione a compagno,
in uso nella sinistra, la DC utilizzò il termine amici
per indicare i propri membri.
Al congresso di Firenze (1959) Moro divenne
Segretario della DC, ma si guardò bene dal promuovere
apertamente l’apertura a sinistra, e avviò quello
che divenne il tratto caratteristico del suo agire politico:
un sottile e ambiguo intreccio di prudenza e innovazione, lungimiranza
e tatticismo. Rinviare e procedere a piccoli passi, era la linea
di Moro, e per ridare coesione a un partito reduce da uno scontro
intestino di particolare asprezza scelse, come si suol dire,
di coprirsi a destra. Il nuovo governò si formò con
l’esplicito
appoggio dei fascisti e Presidente del Consiglio divenne un esponente
della destra DC, Tambroni. Ciò diede
al MSI la sensazione, fondata, di poter puntare a un ruolo
più
di rilievo nel quadro politico e di avere un nuovo spazio di
manovra: così convocò il proprio congresso nazionale,
per la fine di giugno, in quella Genova operaia,
medaglia d’oro della Resistenza, che nel ‘48 era
praticamente insorta.
 
 
Migliaia di portuali, ma anche di ragazzi con le magliette a
strisce che usavano allora, scesero in piazza ben decisi
a impedire la provocazione: gli scontri con la Celere furono
durissimi e ancora si possono vedere nei cinegiornali dell’epoca i frenetici
caroselli delle camionette nella splendida piazza De Ferrari.
Il congresso del MSI non si tenne, ma Tambroni non poteva perdere
la faccia e diede ordine alle Questure di intervenire ovunque
con la massima decisione. Nel corso di una grande manifestazione
sindacale, a Reggio Emilia, la polizia sparò
sulla folla e cinque operai vennero uccisi; ai morti di Reggio
Emilia ne seguirono altri, in Sicilia, e lo sciopero generale
bloccò l’Italia. Che vi fosse o meno un disegno golpista
analogo ai piani del ‘64 e del ‘71, la sterzata autoritaria
venne bloccata e non solo Tambroni fu costretto a dimettersi,
ma la DC capì che l’avvicinamento a sinistra era
una meta obbligata.

Ne era convinto lo stesso governo statunitense, che con la presidenza Kennedy aveva assunto in politica estera iniziative
di grande apertura, e anche da parte del Vaticano era venuta meno
la posizione assolutamente intransigente di pochi anni prima.
Giovanni XXIII fu probabilmente il più
grande innovatore che la Chiesa cattolica avesse mai avuto e l’enciclica Pacem in Terris (1963) segnò davvero una svolta
epocale: scomparso ogni accento di guerra santa, il compito dei
credenti veniva prospettato come un cammino che doveva coinvolgere
“tutti gli uomini di buona volontà”,
nel comune sforzo per un nuovo ordine mondiale basato sulla coesistenza
pacifica e sull’annullamento delle gravissime diseguaglianze
fra Nord e Sud del pianeta; il Concilio Vaticano II del 1965 sancirà solennemente questa svolta e avviò
profonde trasformazioni interne alla Chiesa cattolica.
Nella DC andavano dunque rafforzandosi le tendenze più
riformiste: sostenute con grande tenacia da brillanti economisti
come Pasquale Saraceno, uno dei più convinti
assertori della politica di piano, e da tecnocrati del calibro
di Mattei, il quale fece del Giorno, quotidiano di proprietà
dell’ENI, il battagliero portavoce di tali idee, esse trovarono
un riscontro particolarmente significativo nell’elaborazione
che veniva maturando nell’area laico-socialista. Sotto questo
aspetto un ruolo importante giocarono gli uomini che un tempo
erano stati l’anima del Partito d’Azione, e che si
erano ritrovati nel PRI, diretto da un sincero riformista come
Ugo La Malfa, o nel PSI, mentre decisamente di
basso profilo fu il contributo del PSDI. Una parte del PSI, tuttavia,
quella legata alle posizioni di Basso, si batté fermamente
contro il centrosinistra, che giudicava un’operazione trasformistica
in cui le componenti riformatrici si sarebbero trovate in completa
subalternità rispetto alle istanze conservatrici della
DC: la radicalità di questa opposizione non riuscì
poi a trovare alcuna mediazione con la linea di Nenni, e spinse
un consistente gruppo di sindacalisti, guidati da Vittorio Foa,
e di intellettuali a staccarsi definitivamente dal PSI e a fondare
(1964) il PSIUP (Partito Socialista di Unità
Proletaria). Al contrario, altri esponenti della sinistra interna,
come Riccardo Lombardi, videro nel centrosinistra
una grande occasione per spezzare il ruolo egemonico esercitato
dalla DC e attivare progetti di inovazione strutturale proprio
a partire dall’entrata nella “stanza dei bottoni”.
Era un’ipotesi che si rifaceva senz’altro a quella
strategia delle “riforme di struttura”
prospettata dallo stesso PCI, rovesciandone però l’impianto
originario, che invece aveva come presupposto la cacciata della
DC all’opposizione.
 

Fu un dibattito forse fra i più interessanti in cui la
sinistra italiana si sia mai cimentata: per la prima volta il
punto di partenza non era la disputa ideologica, ma l’analisi
concreta della situazione concreta. Nel PCI non furono pochi coloro
i quali, come Giorgio Amendola, assunsero una
posizione possibilista, attenta agli sviluppi che poteva assumere
un quadro fino a quel momento dominato dalla pervicace chiusura
centrista della DC; prevalse tuttavia lo scetticismo nei confronti
di un esperimento che aveva di fronte a sé enormi incognite.
La più pesante fra esse era certamente rappresentata dall’aperta
ostilità della maggioranza di Confindustria, che vedeva
nel centrosinistra una pericolosa base d’appoggio alle rivendicazioni
sindacali; oltre a tutto il governo stava preparando la nazionalizzazione
dell’energia elettrica, che avrebbe messo fuori
gioco le grandi aziende private che fino allora avevano controllato
questo decisivo settore dell’ economia. I 1500 miliardi
(corrispondenti grosso modo a 23.000 mld di oggi, ovvero 12,5
mld di euro) pagati dal governo come indennizzo furono decisamente
un buon affare per le società elettriche, ma l’avversione
degli industriali per la nuova prospettiva politica fu accentuata
da alcune misure, peraltro piuttosto blande, di tassazione dei
profitti derivanti dai guadagni sulla compravendita di azioni.
Un ulteriore motivo di attrito fra grandi imprese e governo fu
la proposta di legge sull’urbanistica, che intendeva introdurre
alcuni elementi di regolamentazione in un settore, quello edilizio,
che, come si è visto, era fonte di proventi elevatissimi:
l’idea era quella di consentire ai Comuni di espropriare
le aree che sarebbero state oggetto di edificazione, per evitare
il solito gioco speculativo in base al quale si compravano a basso
prezzo terreni che, una volta divenuti fabbricabili, avrebbero
visto il loro valore aumentare in modo astronomico. Si trattava,
insomma, di una riforma di elementare equità, ma quel che
è troppo è troppo: dalla Confindustria e dalla stampa
conservatrice si gridò al tentativo di “sovietizzare”
la terra, e la DC fece bruscamente marcia indietro.
Ciò non le impedì, alle elezioni politiche del 1963,
di arretrare pesantemente, scendendo per la prima volta al di
sotto del 40%: con il 38,3% il distacco dai comunisti, saliti
al 25,3%, restava ancora assai ampio, ma non sembrava più
incolmabile come quello del ‘48. Una ragione in più
per procedere più speditamente alla convergenza DC-PSI
che, già sperimentata in alcune giunte locali come quella
di Milano, si formalizzò nel dicembre 1963, con la costituzione
del primo governo organico di centrosinistra,
con Moro Presidente del Consiglio e Nenni Vicepresidente.

Che l’alleanza fosse ancora instabile e comunque soggetta
a forti elementi di destabilizzazione fu chiaro appena pochi mesi
dopo: in seguito all’ennesima crisi di governo, il Presidente
della Repubblica Antonio Segni, notoriamente
poco favorevole all’esperienza del centrosinistra, convocò
al Quirinale (luglio 1964) il generale De
Lorenzo, comandante dell’Arma dei Carabinieri.
Nulla si seppe di quel colloquio, ma l’iniziativa fece pensare
al peggio (era casuale che proprio in quei giorni si svolgesse
in Italia un’importante esercitazione della NATO?), tanto
che i socialisti annullarono immediatamente le perplessità
sul proprio rientro al governo e permisero che la crisi si risolvesse
in pochi giorni. Cosa fosse accaduto in quelle ore lo si seppe
solo alcuni anni più tardi, quando una commissione parlamentare
indagò espressamente su quei fatti: il generale De Lorenzo
aveva allestito un’unità speciale ad altissimo grado
di addestramento e capacità operativa, dotata di mezzi
corazzati e di armamenti sofisticati, un “piccolo esercito
personale, superiore per disciplina ed efficienza al resto delle
forze armate” (Ferruccio Parri, articolo sulla rivista L’Astrolabio). Insomma, una vera e propria struttura
golpista, che avrebbe dovuto agire nell’ambito del cosiddetto piano “Solo”: gli alti comandi dei
carabinieri (solo i carabinieri) avevano ricevuto un
dettagliato programma antisovversivo, che prevedeva l’occupazione
delle stazioni radiotelevisive e degli uffici pubblici, l’arresto
su larga scala degli esponenti politici e sindacali pericolosi,
la chiusura delle sedi di partito. Non si trattò, insomma,
di un vero e proprio tentativo di colpo di stato,
perché l’ordine di far scattare il piano non fu impartito,
ma senza dubbio ci si andò vicinissimi.
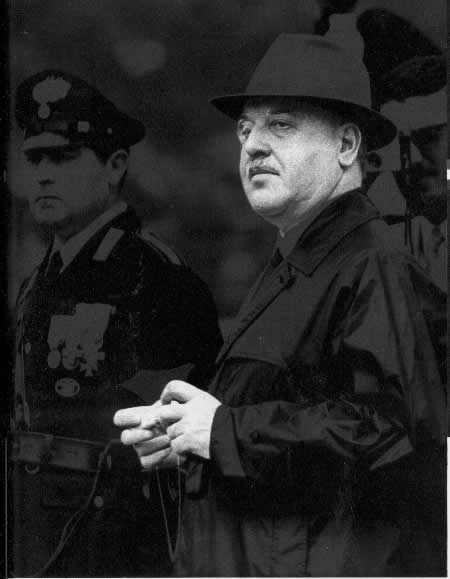   
Le riforme annunciate - urbanistica, fisco, università,
programmazione economica, istituzione delle Regioni - si persero
nelle sabbie mobili dell’indecisione e della politica del
giorno per giorno, e l’unica che fu realizzata fu quella
che portava l’obbligo scolastico a 14 anni e unificava le
varie tipologie di istruzione inferiore nell’attuale scuola
media, ma sempre all’interno di un sistema scolastico a
dir poco arcaico.
L’elezione a Presidente della Repubblica del socialdemocratico
Giuseppe Saragat suggellò il riavvicinamento
fra PSI e PSDI, che nel 1966 si riunirono nel PSU (Partito Socialista Unificato, che tre anni dopo si spaccò
nuovamente), ma ciò non servì molto a riequilibrare
in termini di effettivo potere il ruolo dei socialisti rispetto
alla DC, che in quegli anni di immobilismo (almeno dal punto di
vista delle riforme) capì prima di qualsiasi altro partito
che fare politica in una società moderna significa innanzi
tutto promuovere e mantenere una rete permanente di rapporti con
i vari gruppi sociali: se l’interclassismo fu all’
inizio una scelta ideologica della DC, da tradurre in pratica
a partire dalle spinte che provenivano da una base elettorale
eterogenea, e quindi portatrice di esigenze spesso in contraddizione
fra loro, in seguito divenne una vera e propria strategia di costruzione
del consenso: non si trattava più di farsi condizionare
dalla società, bensì, al contrario di dominare le
forze che essa sprigionava e di armonizzarle in un disegno consapevole. La politica clientelare (i clientes,
nell’antica Roma, infatti non erano tanto coloro che assillavano
i potenti, quanto le persone che si mettevano sotto la loro protezione
e ne ricevevano i favori) riacquistò il suo antico significato
e la DC seppe farsi interprete e guida al tempo stesso di un insieme
di interessi e aspirazioni come nessun altro partito fu in grado
di fare.
L’occupazione dello Stato, o, per meglio
dire, la ricostruzione e l’ampliamento dello Stato sotto
forma di apparato di formazione e di controllo del consenso,
era certo una pratica eticamente discutibile, ma sicuramente
fu una risposta reale e a suo modo assai efficace ai problemi
del paese. Il problema casomai consisteva nel fatto che si era
venuto a creare un sistema che per definizione era inefficiente:
laddove gli interessi personali o politici erano diventati il
criterio prioritario con cui amministrare un ente, erogare contributi,
gestire aziende, spendere denaro, tutto ciò non poteva
non ritorcersi contro il sistema stesso. Il sogno di Mattei,
di avere un’industria
pubblica all’avanguardia, in grado di competere ai massimi
livelli e di fornire risposte positive allo sviluppo, si deformò
al punto da divenire la negazione di tutto questo: colossi industriali
ridotti a macchine elettorali che inghiottivano miliardi, che
producevano ricchezza per ristretti centri di potere. Fu proprio
il successore di Mattei alla direzione dell’ENI, Eugenio Cefis, a elevare tale pratica a livelli mai
raggiunti in precedenza: nata dalla fusione di due grandi aziende,
la Montecatini e l’Edison, la Montedison fu
scalata (dare la scalata a una società significa rastrellarne
le azioni fino ad acquisire la maggioranza, o perlomeno una
robusta quota, del pacchetto azionario, prendendo quindi il
controllo dell’azienda:
è ovviamente un’operazione molto costosa e che richiede
notevoli abilità di manovra per dissimulare il proprio
intendimento, stringere alleanze, ecc.) dall’ENI e Cefis
stesso ne assunse la presidenza, facendone un impero finanziario,
tanto potente quanto intrinsecamente fragile.
 Dove i legami fra potere politico e interessi economici diventarono
ben di più di un discutibile modo di amministrare, ma
si configurarono come un vero e proprio sistema illegale, fu
in Sicilia, in Calabria e in Campania. Dove i legami fra potere politico e interessi economici diventarono
ben di più di un discutibile modo di amministrare, ma
si configurarono come un vero e proprio sistema illegale, fu
in Sicilia, in Calabria e in Campania.
Con la fine degli anni ‘50
la mafia, la ‘ndrangheta e
la camorra non furono più il semplice
braccio armato dei latifondisti, ma divennero esse stesse “aziende”:
la speculazione edilizia e gli appalti pubblici furono una
fantastica miniera d’oro (negli anni recenti sostituita
dalla miniera ancora più ricca del traffico d’armi,
del racket, del commercio di eroina), la cui sicurezza era
garantita da una polizza d’assicurazione solidissima,
il potere politico.
Salvo Lima e Vito Ciancimino,
della corrente andreottiana, furono assessori ai lavori pubblici
(un ruolo chiave, com’è intuitivo) di Palermo dal
1956 al 1964, e successivamente anche sindaci, proprio nel periodo
in cui la città fu devastata dall’assalto mafioso
e dalla cementificazione.
|