Giancarlo De Cataldo
Giancarlo De Cataldo (Taranto, 1956) fa il magistrato a Roma, città che ama moltissimo.
Da quando ha cominciato a scrivere ha portato nel poliziesco italiano un'indispensabile dose di concretezza, ancorando la narrazione a situazioni plausibili, a vicende criminali tragicamente realistiche.
Si è misurato non solo con la narrativa, ma anche con la saggistica sociologica, con il teatro, e , soprattutto, con l'attività di sceneggiatore, sia per la televisione che per il cinema.
- Nero come il cuore, Interno Giallo, 1989; Mondadori, 2001; Einaudi, 2006
- Camici bianchi e impronte digitali, Il Pensiero Scientifico, 1992 (con Tiziana Pomes)
- Contessa, Liber, 1993
- Il padre e lo straniero, Manifestolibri, 1997, 2001; E/O, 2004; Einaudi, 2010
- Onora il padre. Quarto comandamento, Mondadori, 1999; Einaudi, 2008 (pseud: John Giudice)
- Teneri assassini, Einaudi, 2000
- Romanzo criminale, Einaudi, 2002
- Nelle mani giuste, Einaudi, 2007
- Fuoco!, Ambiente , 2007
- Trilogia criminale: Nero come il cuore. Onora il padre. Teneri assassini, Einaudi, 2009
- I traditori, Einaudi, 2010
- La forma della paura, Einaudi, 2010 (con Mimmo Rafele)
- Giudici, Einaudi, 2011 (con Andrea Camilleri e Carlo Lucarelli)
- In Giustizia, Rizzoli, 2011
- Io sono il Libanese, Einaudi, 2012
- Int'allu Salento, Ad est dell'equatore, 2012
- Suburra, Einaudi, 2013 (con Carlo Bonini)
- Nell'ombra e nella luce, Einaudi, 2014
- Giochi criminali, Einaudi, 2015
- La notte di Roma, Einaudi, 2016 (con Carlo Bonini)
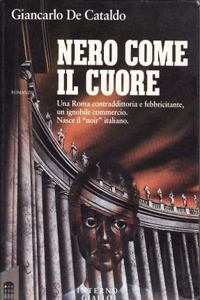       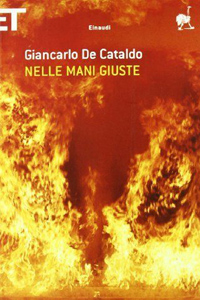  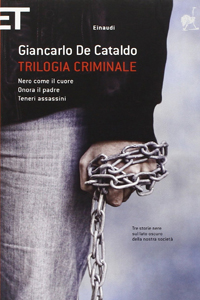    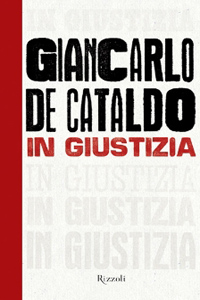   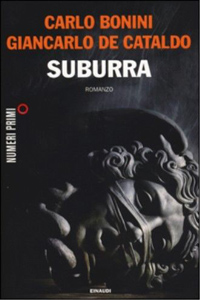   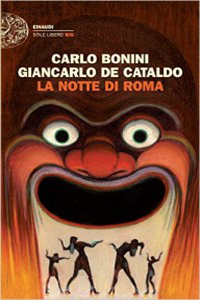
Film dai suoi libri:
- Romanzo criminale (2005), di Michele Placido. Con Stefano Accorsi, Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart, Riccardo Scamarcio
 |
Mario Tirino
Giancarlo De Cataldo. I volti di un narratore |
Questa intervista è stata realizzata in due tranche, via e-mail, grazie alla eccezionale disponibilità di Giancarlo De Cataldo, che qui intendo ringraziare pubblicamente con la massima riconoscenza. L’impostazione del colloquio è volta a differenziare quest’intervista dalle altre, al fine di rappresentare uno sguardo ad ampio raggio sull’autore De Cataldo in tutte le sue sfaccettature ivi comprese le attività saggistiche, televisive, teatrali, cinematografiche) e non, com’è stato fatto più volte, soffermarci solo sugli ultimi suoi lavori di successo
Il grande successo è arrivato con Romanzo criminale (2002), ma lei ha una solida attività narrativa alle spalle. Può parlarci, innanzitutto, del percorso che l’ha portata a riscrivere Nero come il cuore (1989) e a come, nella versione del 2002, è riuscito ad amalgamare la componente thrilling con tematiche sociali (il razzismo, la vendita d’organi) e individuali (la delusione professionale del disincantato avvocato Bruio)?
Nella riscrittura io non toccai la trama, che rimase inalterata. Rimaneggiai alcuni elementi di contorno per attualizzarli. Ma soprattutto, fra la prima e la seconda stesura, ero cambiato io. Era cambiata la mia visione del mondo. Avevo abbandonato molte delle ingenuità del “vecchio” avvocato Bruio. Mi ero ispessito e avevo dovuto digerire molte delusioni. Alcuni elementi che facevano, nell’89, la diversità di questo personaggio erano indubbiamente datati, ma più che altro non corrispondevano più al mio sentimento. E verso il mondo e verso la scrittura.
Da qui la sensazione un po’ artificiosa che la riscrittura può dare, e sicuramente ha dato, al lettore attento.
Nel 1993 lei ha pubblicato, presso un piccolo editore, un’altra opera, Contessa. Purtroppo il libro è introvabile. Ce ne può parlare? Che relazione con la celebre canzone contestataria di Pietrangeli? Ci sono possibilità di ristampa?
Il titolo gioca sull’ambiguità di una nobildonna assassinata e sul suo passato di sinistra, simboleggiato da una celebre canzone del tempo. È un romanzo sulla perdita dell’innocenza e, ancora una volta, sulla delusione del vivere. Ristampare? Mah, non so, io sono ancora più diverso da Contessa che da Nero come il cuore. Forse su qualche bancarella si trova ancora qualche copia spuria…
Anche in Il padre e lo straniero lei dimostra una raffinata capacità di scandaglio psicologico, nonché una conoscenza delle dinamiche socio-culturali di ampi settori della società contemporanea (gli impiegati ministeriali, gli immigrati illegalmente arricchiti). Come è arrivato a una sintesi così equilibrata di dolore, speranza e thriller?
Dall’esperienza personale, dalla sofferenza personale, dalla liberazione personale. È sempre così, nei libri molto amati. E Il Padre e lo straniero è un libro molto amato. Un figlio che ha stentato a trovare amici (uscì in sordina nel ’97 per la Manifestolibri, fu ristampato nel più assordante silenzio quattro anni dopo e solo adesso se ne parla un po’, merito, ovviamente, di Romanzo Criminale…).
Lei è anche stato in grado di rappresentare gli immigrati senza la retorica di un certo pauperismo solidale per cui essi ci vengono sempre e comunque propinati come creature angeliche e senza macchia. Eppure è chiaramente dalla loro parte. Quanto ha contato in ciò la constatazione, da uomo e magistrato, delle ingiustizie che essi subiscono quotidianamente?
Vivo circondato da immigrati. Il portiere del mio stabile è immigrato. L’idraulico è immigrato. Fra non molto avremo poliziotti immigrati, infermieri immigrati già girano nei nostri ospedali, l’assistenza degli anziani e dei disabili è da anni esclusiva funzione degli immigrati. Io sono immigrato dalla Puglia a Roma. Sulla paura dell’immigrazione si stanno costruendo ideologie e poteri. Ma io non voglio vivere nella paura. Voglio vivere nella libertà e nell’armonia. Voglio vivere in una città in cui ci sia spazio e dignità per tutti. Chi commette delitti va punito, ma l’equazione immigrazione/criminalità è inaccettabile. Tipica della fase meschina e livorosa che sta vivendo il nostro Paese.
In Teneri assassini (2000) ha scelto la forma breve dei racconti. Ci è parso che questa scelta in qualche modo sia stata “guidata” dalla stessa materia narrativa, e cioè dalle giovani esistenze che si trascinano, esplodono o implodono ad una velocità assurda che non consente loro neppure un respiro (narrativo e non) più ampio. È così?
Non saprei. Davvero, mi capita sempre più spesso che attenti lettori colgano aspetti della mia scrittura che mi sfuggivano mentre scrivevo e che continuano a sfuggirmi quando mi vengono offerti come chiave di lettura. Prendo atto. Ma per me la scrittura è anche una trance, un piacere artigianale e solitario.
Può parlarci delle altre sue esperienze con il racconto in antologie e raccolte?
Premesso che non c’è niente di turpe nello scrivere un racconto “su commissione” (se il tema è interessante e sentito, il racconto su commissione può essere un ottimo banco di prova per lo scrittore - artigiano), posso dire che ho partecipato a qualche antologia solo se il progetto mi interessava.
Nel caso di Viva l’Italia (Fandango) c’era l’idea di una raccolta contro lo strisciante razzismo neopadano. Per Dieci storie di pace (Piemme) il progetto prevedeva la devoluzione dei diritti a Emergency, ottima cosa, non le pare? In Giallo Natale di Mondolibri ero con tutta la pattuglia Stilelibero, e come tirarsi indietro? Per Killers and co. si è trattato di un debito di amicizia verso quell’autentico gentiluomo di Gianfranco Orsi, e anche dell’opportunità di cimentarmi con un “divertissement”: il giallo storico. Per il resto, dico molto più spesso di no che di sì. Colgo l’occasione anche per ricordare che, io come tanti altri, oggi esigiamo dagli editori che i nostri libri siano pubblicati su carta riciclata o certificata. È un progetto di Greenpeace al quale ho aderito con entusiasmo: che senso ha scrivere se le nostre parole provocano la distruzione di una foresta?
Onora il padre, in quanto novelization di una serie tv, è un esperimento assai raro nel nostro panorama letterario. Purtroppo anche questo è un lavoro poco noto. Ce ne dà qualche cenno?
Onora il padre nasce da una sceneggiatura di ferro scritta a sei mani con Fausto Brizzi e Marco Martani, che mi hanno lasciato mano libera, generosamente, sull’aspetto letterario. È la storia di un poliziotto che scopre che il serial-killer sul quale sta indagando potrebbe essere il padre che credeva morto da anni. È una storia dolente e molto “classica”. Ecco, paradossalmente, oggi mi sento abbastanza vicino a quelle atmosfere, e credo che Onora il padre sia ancora un romanzo godibile, anche se fortemente condizionato dall’origine televisiva.
Prima di passare al suo capolavoro, se è d’accordo, facciamo una breve panoramica sulla sua produzione saggistica, iniziando da Minima criminalia, in cui mostra un lodevolissimo proposito di comprendere quella realtà carceraria che spesso i magistrati non tengono nel giusto rilievo. Che frequentazioni carcerarie ha avuto?
Sono stato giudice di sorveglianza per cinque anni. E ho conosciuto mille tipi umani di grande interesse, oltre a autentici farabutti, squallidi opportunisti, teneri assassini e via dicendo. Una palestra di vita che non potrò mai dimenticare.
Ha mai letto le bellissime recensioni on-line di un detenuto, Nicola Sansonna, che, tra gli altri, ha recensito anche Romanzo criminale? Non pensa che le politiche giudiziarie dei vari governi succedutisi nell’ultimo sessantennio non abbiano mai decisamente puntato su attività di recupero e reinserimento dei delinquenti, come quella di incentivare i consumi culturali?
Non ho letto queste recensioni, ma rimedierò subito. Credo che le politiche sul reinserimento siano ondeggianti. A fasi di grande apertura seguono immancabilmente momenti di gretta chiusura, e non tutti i governi hanno avuto lo stesso atteggiamento. Il carcere è frequentato, e continua ad esserlo, da persone fortemente motivate a lavorare per il reinserimento. L’idea che chi ha sbagliato possa avere una chance di recupero è dura da far digerire al senso comune. Ma non bisogna rinunciare mai a crederci. Si tratta di spiegare che alla società nel suo complesso una politica di reinserimento conviene più di una politica di mera repressione.
Con Tiziana Pomes, ha scritto Camici bianchi e impronte digitali, un libro sulle tracce della medicina nella letteratura poliziesca, segno di una passione per il genere che l’ha portata a scrivere anche saggi e recensioni su quotidiani e riviste. Ci parli un po’ dell’esperienza, da scrittore, di commento e analisi dell’opera di un collega.
Tiziana è mia moglie, vittima da decenni delle mie paranoie letterarie, mia prima lettrice e critica severissima, molto più severa e, devo ammetterlo, abile di me nello scovare i buchi neri di una trama o le cadute di stile di un paragrafo. Sia lode a lei! Camici bianchi è un’antologia di brani legati da un’analisi del rapporto fra medicina e investigazione. Quanto alle recensioni, io non sono un critico e mi vanto di non esserlo. Sono un lettore onnivoro. Godo del privilegio di ricevere libri in lettura (un grande piacere, ve lo assicuro!) e a volte, quando un lavoro mi colpisce, lo segnalo. Così anche altri potranno godere, se ne hanno voglia, dello stesso piacere che ho provato io leggendolo.
Come nasce Terroni? Che rapporto affettivo ha con la terra dov’è nato, la Puglia, e con il Meridione in generale?
Terroni (insieme ad Acidofenico) è il mio “regolamento di conti” con la questione delle origini. Il Sud è per me una condizione esistenziale, più che un luogo geografico. Per questo non mi sono mai considerato uno scrittore del Sud, ma un meridionale che scrive. Che è cosa ben diversa. E Terroni rivela anche la mia vecchia passione per il réportage: scovare i posti, annusarli, leggerne le trame meno appariscenti, riviverle riproducendole… uno dei tanti mestieri che mi sarebbe piaciuto fare, e che ho lambito avendo la fortuna di trovare anche dei lettori interessati.
Un lavoro come I giorni dell’ira, realizzato a quattro mani con lo psichiatra Paolo Crepet, si presta ad essere una corretta analisi di un fenomeno - i matricidi - che tuttavia è stato fatto oggetto di indegne strumentalizzazioni mediatiche. Cosa ne pensa del voyeurismo e della morbosità con cui, senza generalizzare, una buona parte della cronaca televisiva tratta casi come quello di Erika e Omar?
Voyeurismo, ha detto bene. E speculazione sulla paura. C’è un sottile gioco che poi va sempre a finire alla solita conclusione obbligata: i giovani ci fanno paura, le madri non possono uccidere un figlio, i giudici non capiscono niente e via dicendo. Tutto all’insegna di un carnevale francamente monotono.
Romanzo criminale è certamente il romanzo più famoso. Eviteremo di ripetere le solite domande che le sono state poste sull’argomento (il rapporto storia-fiction, la storia della Banda della Magliana, le ascendenze ellroyane, il doppio ruolo di magistrato/scrittore) che (ci) annoierebbero tutti. Le chiedo, invece, se davvero la selezione del materiale da pubblicare è stata indolore, come ha dichiarato in un colloquio, oppure se il sacrificio le è costato pagine che, magari, pensa di utilizzare in altri contesti.
Grazie per aver evitato la solita tiritera sul magistrato scrittore. La selezione del materiale è sempre indolore quando hai fatto la tua scelta. In quel momento ciò che non sarà scrittura cessa di esistere e una volta presa una strada non sono ammessi ripensamenti. Quindi, niente cronache criminali collaterali nel cassetto.
Naturalmente, Romanzo criminale è anche la sua sfida più ambiziosa. Una sfida, secondo noi, alimentata da una fortissima istanza etica ed epica: la necessità/dovere di raccontare una parte torbida della nostra storia nazionale. Lei spesso si schermisce quando le fanno complimenti “pesanti”: non ritiene, però, ridicolo negare che questo libro è un atto di coraggio, civico e artistico, senza pari nel nostro attuale panorama letterario?
Mi schermisco perché non riesco a prendere sul serio né l’enfasi né il ruolo dello scrittore. I complimenti mi lusingano e mi imbarazzano, e le critiche mi feriscono. È così naturale!
La strutturazione di microtrame per ciascun personaggio ne ha potenziato la credibilità e la solidità.
Anche le mentalità comuni a certi settori sono narrate con altissima attendibilità. Come ha fatto, ad esempio, a riportare gli stati d’animo delle forze dell’ordine nei confronti dei partiti politici all’indomani del rapimento di Moro?
Con la pratica della vita.
Un altro punto di cui parleremmo volentieri a lungo è la figura del Vecchio. Qualcuno ha obiettato che si tratta di una via di fuga per risolvere certi punti nevralgici del racconto. In realtà a me è parsa un’icona ricca di risonanze mitiche e nello stesso tempo un’inquietante filiazione di intrecci allucinanti fra (anti)Stato, logge massoniche e criminalità organizzata. C’è poi l’elemento del gioco. Quanta fatica e quale elaborazione le è costata una figura così complessa?
Nasce da una scommessa: in quegli anni si parlava tanto del Grande Vecchio, proviamo a immaginarlo in carne e ossa, mi sono detto. Ne è uscito il ritratto di un bizzarro anarchico, metà servitore e metà artefice della Storia. Uno che non fa progetti perché il suo unico progetto è la sopravvivenza dell’esistente. I progetti, pensa il Vecchio, sono tutti pericolosi.
La Storia, prima o poi, punisce i sognatori e gli ambiziosi. Il Vecchio conosce la ubris e conosce la dike. Potrà non piacere, ma è così.
Altro elemento di pregio di Romanzo criminale è il lavoro linguistico che concerne tantissimi gerghi e dialetti. Ma è indubbiamente sul territorio del romanesco che lei ostenta un’invidiabile consapevolezza delle mutazioni antropologiche della lingua. Quanto “orecchio” ha avuto per il dialetto romano, lei pugliese, per riprodurne tutte le sue sottili sfaccettature?
In realtà si tratta di un gergo bastardo, mezzo classico e mezzo inventato sul momento dai veri “maglianesi” che ho incontrato. Parlavano davvero così, e hanno il copywright sull’umorismo macabro e sull’efferatezza del loro “dialogato”.
Oltre che come varietà lessicale, la lingua di Romanzo criminale si fa notare per la sua intrinseca ritmicità, come ben ha notato Camilleri, che rende scorrevoli oltre 600 pagine. La ricerca del ritmo è una delle costanti del suo lavoro sulla lingua, anche attraverso divisioni in parti, capitoli, sottocapitoli e l’utilizzo di materiali pseudo-documentali veridittivi (rapporti giudiziari, appunti, ecc.). Quanto conta, in tutto ciò, quello che lei ha definito l’aspetto mistico dell’attività letteraria e quanto la capacità di progettare e razionalizzare un complesso così grande di flussi narrativi?
L’aspetto mistico è inspiegabile, si vive solo scrivendo, è il rifugio estremo di ogni scrittore, e ognuno ha il suo personale e non comunicabile. L’aspetto mitico attiene ai moti oscuri dell’animo umano che si dispiegano attraverso le azioni dei personaggi, e non è mutato dai tempi di Sofocle.
L’utilizzo dei materiali discende dall’insegnamento di Bachtin sulla satira menippea come forma letteraria tipica delle società nei momenti di transizione. La progettazione è una serie di scalette che incrociano destini, eventi storici e caratteri dei personaggi. Comporta anni di studio finché non sei padrone della materia e sai esattamente tutto dei tuoi personaggi, come vestono, cosa pensano, che mangiano, chi amano, che musica ascoltano. La tecnica compositiva, sotto questo profilo, mi viene dalla frequentazione dei corsi di sceneggiatura e dalla manualistica americana, a sua volta sintesi divulgativa dell’antica sapienza narratologica, da Aristotele a Propp. Più complesso è il disegno narrativo, più ampia l’interazione di questi elementi. Siccome mi piace pensare alla scrittura come a un’attività artigianale, diciamo che la gran parte del lavoro consiste nello scartavetrare la parete, scegliere la tinta giusta, e saper maneggiare il pennello limitando al minimo le sbavature.
È un domandone, certo, ma lei non è uomo da piccoli ostacoli: dunque, cos’è e cos’è stata per lei Roma, la sua gente, i suoi odori, la sua secolare indolenza?
In una battuta: la città che amo, dove amo vivere, al punto da non riuscire a immaginarmi altrove. Nell’indolenza c’è accoglienza, nella superficialità saggezza, nell’aggressività più apparenza che sostanza. Alla fin fine sono sbarcato qui da immigrato e sono stato accolto. Ne sono grato a Roma e ai romani.
So che non le piacciono le polemiche accademiche. Tuttavia, senza voler polemizzare eccessivamente, cosa ne pensa dell’articolo che Giulio Ferroni, tra l’altro uno dei maggiori studiosi di letteratura italiana, ha pubblicato qualche giorno fa sul «Corriere della Sera» in cui si scaglia contro quella che definisce (ancora!) “paraletteratura”? Non pensa che ormai il thriller, il giallo, l’horror e la fantascienza abbiano pieno diritto di entrare nel gotha letterario, non per quei talenti che si avvicinerebbero alla cosiddetta “letteratura alta”, ma per un’intrinseca capacità di raccontare mutazioni antropologiche, sociali, mediali della contemporaneità?
Ancora? Ma non abbiamo cose più serie di cui occuparci?
Lei ha più volte dichiarato di essere lettore onnivoro. Proviamo a fare un po’ d’ordine? Dunque: ha scritto prefazioni per tre autori italiani (Quattrucci, Avellino, Saladini). Come vede il panorama del giovane giallo/noir italiano? E tra i suoi più o meno coetanei chi legge, chi ama?
Mi capita di segnalare manoscritti, se un amico mi chiede un intervento e il suo lavoro mi convince non mi tiro indietro. Dei tre libri che ha citato, per intenderci, mi hanno colpito il coraggio di Saladini di mettersi a cavallo fra i generi, la qualità della scrittura di Avellino, la robusta tensione morale di Quattrucci. Leggo molto volentieri però anche i nostri “classici”, da Macchiavelli a Carlotto a Lucarelli, a Simi a Sandrone Dazieri, al grande Camilleri. Mi piacciono Di Cara, Narciso e insomma l’elenco sarebbe lungo. E comprenderebbe riscoperte necessarie come il grande Attilio Veraldi, un vero orafo della scrittura. Il nostrano giallo/noir corre però il rischio di un’involuzione, di diventare “maniera”. È già successo agli americani. Non basta impilare un serial-killer, un poliziotto filosofeggiante e una dark-lady per scrivere un buon noir. Così come non basta citare “Genova” per evocare un noir di sinistra o uno slavo perverso per iscriversi al fronte del noir di destra. Personalmente, avverto l’esigenza di muovermi verso una scrittura “pura”, libera dal feticcio dei generi. Noir compreso.
Cosa predilige del poliziesco americano, a parte Ellroy, ovviamente?
Sicuramente Lawrence Block, Ed McBain, Jim Thompson, Cornell Woolrich, Joe Lansdale, Elmore Leonard, James Lee Burke, i classici, insomma. Mi lasciano molto perplessi i grandi facitori di trame inverosimili, come Deaver, o i minuziosi descrittori di autopsie, come la Cornwell. Fra le nuove leve mi piacciono Dennis Lehane, uno scrittore robusto, e Jason Starr, scanzonato e perfido illustratore di un’America sordida e marginale. Interessante anche James Sallis. Ma non limiterei il discorso agli americani. Non dimentichiamoci, fra i grandi di oggi e di sempre, di Leo Malet, di Manchette, di Izzo, di Vazquez Montalban, e degli inglesi, da Derek Raymond a Robert Wilson (bellissimo L’uomo di Siviglia, bellissimo Una piccola morte a Lisbona) a quello scrittore davvero fuori da ogni regola, quello scrittore esagerato e violentissimo che è David Peace.
Sappiamo che è anche appassionato lettore di Georges Simenon. Quale ritiene, tra i tanti, il contributo più significativo dato da quest’autore al poliziesco?
Bah, qui il discorso si farebbe sterminato! Me la cavo con una battuta: quando “pesco” a Porta Portese un Simenon che non ho ancora letto provo un fremito di piacere. A 360 gradi.
Quali classici “d’autore”, ottocenteschie novecenteschi, preferisce?
Sicuramente i grandi romanzi di formazione dell’Ottocento hanno esercitato un influsso decisivo non solo e non tanto sulla mia scrittura, quanto sulla mia vita. Cito l’amato Balzac, L’Educazione Sentimentale di Flaubert, Dostojevksji, ma anche Dickens e Maupassant. Nel Novecento ho avuto il mio periodo manniano (La Montagna Incantata su tutto), e sono molto attratto, ancora adesso, da Moravia (la sua capacità unica di raccontare la borghesia). Confesso la mia antipatia per Proust e Musil (nessuno è perfetto) e Henry James (tranne Il Giro di Vite e alcuni racconti di fantasmi). Ma ho un posto nel cuore anche per certi autori “minori” o cosiddetti tali, come Capuana, Landolfi, Tozzi. Noterà che prediligo i robusti facitori di trame ai cultori della bella pagina.
A quali riferimenti cinematografici s’è ispirato? Anche qui, da interviste precedenti, credo la lista sia molto lunga…
Welles. Kurosawa. Sergio Leone. Umberto Lenzi, Di Leo e gli altri signori del “poliziottesco”. Takeshi Kitano. Tutti i film di arti marziali (sì, lo so, sta diventando una moda, ma che ci posso fare? La tigre e il dragone mi eccita, La foresta dei pugnali volanti mi commuove!). Scorsese. Coppola. Donnie Brasco. Carlito’s Way. Kubrick. E poi, se parliamo di ritmo, del gioco della vita, di quel vitalismo sfrenato che ho cercato di rappresentare nella crudeltà dei malavitosi di Romanzo Criminale, come non citare il grande Kusturica? Ma insomma, anche a cinema sono onnivoro. Provo solo un leggero senso di fastidio per le operine minimaliste in interno borghese in cui lui e lei ci mettono i primi cinquanta minuti per decidersi a finire in posizione orizzontale e gli altri cinquanta per capire se si sono divertiti o no.
In che modo ha contribuito alla riduzione cinematografica di Romanzo criminale? Perché Michele Placido ha sostituito Marco Tullio Giordana alla regia? Quali aspettative nutre verso il progetto?
La mia collaborazione è stata abbastanza sullo sfondo.
D’altronde, il passaggio dalla letteratura al cinema comporta un sano tradimento, e l’unica cosa che conta è che alla fine i partners siano entrambi soddisfatti. La domanda sulla defezione di Marco Tullio Giordana la girerei al diretto interessato. Placido ha le giuste caratteristiche di forza e anche di attenzione al lato sentimentale della vita. Dal progetto mi aspetto molto non tanto per me, quanto per il pubblico. È lui l’unico giudice che veramente conta.
Nota una significativa discrepanza nel panorama culturale italiano, segnato, da un lato, da una produzione narrativa di crescente qualità e sempre più legata all’attualità, e, dall’altro, da una cinematografia non più in grado di cogliere gli snodi vitali della società contemporanea (con le significative eccezioni di Matteo Garrone, Ferzan Ozpetek e Paolo Sorrentino)?
Non c’è una crisi né di scrittura, né di regia, né di attori.
C’è una crisi di produzione. Di industria. È questo il punto dolente del nostro cinema. La stessa TV, d’altronde, quando si impegna in progetti seri, è in grado di sfornare eccellenti fiction di alta qualità. Se in un anno si producono cento film è un discorso, se se ne stiracchiamo quindici - sedici siamo già all’agonia.
Eppure, per un’arte industriale quale è il cinema, non crede che questo sia letale? Ed inoltre, a parte pochi isolati talenti, non manca forse una specializzazione dei diversi ambiti: come hanno dichiarato più registi del vecchio corso, oggi è proprio il nodo della scrittura ad essere deficitario, poiché molti, troppi registi s’improvvisano sceneggiatori (laddove, un tempo, esisteva una solida scuola di artigiani del racconto). Che ne pensa?
Ovviamente, il regista che si improvvisa sceneggiatore non sempre dà buoni esiti, ma questo è un problema legato al sentirsi “autori” di molti registi, sia sotto l’aspetto positivo, cioè di voler esercitare un doveroso controllo sul prodotto nella sua interezza, sia sotto quello negativo del narcisismo. L’artigianato del racconto esiste ancora, comunque, glielo assicuro. Anzi, semmai c’è da lamentare la mancanza di qualche “acuto”.
Ma siamo sempre lì: se tu proponi un distacco dalle regole, devi faticare molto per imporlo. Perché in giro - parlo a livello di produzione e network - c’è pochissima voglia di rischiare.
Lei ha lavorato anche per la tv. Quali sono state le luci e le ombre di quest’esperienza? Crede che, per i narratori italiani, cimentarsi con la serialità televisiva possa costituire una solida base per prepararli alla sceneggiatura cinematografica?
Molte luci e poche ombre, confesso. Per esempio, non sono mai stato censurato.
La TV è artigianato allo stato puro, quando bene interpretata. E, come dicevo prima, la si può interpretare benissimo. Credo che anche in TV il problema sia di struttura produttiva più che di idee o di cast. Un maggiore pluralismo delle fonti garantirebbe più ricchezza e originalità di materiali: quando capiremo che nel nostro Paese ci sono molte realtà di immigrazione, cominceremo a vedere poliziotti multietnici, medici senza frontiere, eroi quotidiani colorati e via dicendo. A qualcuno potrà far venire l’orticaria, ma se in America non ci fosse stata una fortissima comunità greca non avremmo mai avuto Kojak, senza gli italo-americani non ci sarebbe stato Colombo (con un protagonista, Peter Falk, di origine russa!) e via dicendo. Quanto alla sceneggiatura, non solo
la TV è ottima maestra, ma la scrittura di scena in sé è ottima maestra per la scrittura letteraria. Si tratta, ovviamente, di impadronirsi di un corpus di regole e poi di tradirle sapientemente.
Le va di dare un giudizio sulle serie poliziesche televisive italiane? Ad esempio: Distretto di polizia, Carabinieri, Il Capitano, RIS, La squadra.
Ho scritto alcuni episodi della Squadra. Un vero laboratorio da salti mortali: far entrare storie “sporche”, verosimili, in un contenitore di mezzi estremamente angusti. Gran bella esperienza! Si impara davvero la quadratura del cerchio!
La Squadra è una serie neorealistica. Distretto è più ricca (produttivamente), e gode di una pattuglia di attori eccezionali. Conosco poco le altre serie, quindi non posso pronunciarmi. Osservo che un po’ di coraggio in più nel raccontare non solo poliziotti perfetti, ma anche perfettibili, o al limite qualche “cattivo tenente”, non guasterebbe. Ma anche questo sarà possibile quando avremo - e se avremo - più canali in concorrenza fra loro.
Ha scritto anche un testo teatrale, Acido fenico. Cosa ha provato quando il suo testo è stato messo in scena dal gruppo Koreya, con musiche dei Sud Sound System? Vorrebbe lavorare ancora in quest’ambito?
Esperienza esaltante. Il teatro è pura vita, intelligenza e povertà. Ho provato emozione nel rivedere il mio testo. Il teatro è scrittura scenica, cambia ad ogni rappresentazione. Il testo sarà anche mio, ma il merito di tutto ciò che si muove è di Koreja e della Papa Gianni and co. Solo che il teatro è difficile, maledettamente difficile!
La camorra, per questioni geografiche, è tema che mi tocca da vicino. L’attualità offre, con la faida che insanguina Scampìa e Secondigliano, spunti ad intellettuali e artisti di produrre opere di denuncia. La musica napoletana (Teresa De Sio, Nino D’Angelo), che ha tempi di reazione più rapidi, ha risposto. La letteratura, che, in passato, non ha saputo raccontare con sufficiente durezza questi drammi, riuscirà a partecipare alla creazione di un clima di risorgimento civile della città?
Speriamo. A Napoli ci sono ottimi scrittori, da Braucci a Montesano a Ferrandino. Ma la sua domanda lascia intendere che lo scrittore dovrebbe farsi anche cronista della storia del suo tempo. E questo non è propriamente corretto. Un’opera ha, ai miei occhi, più pregio se del tempo presente coglie alcuni spunti, non se si limita a riprodurlo o a lanciare urli scomposti, come si faceva un tempo all’epoca della letteratura militante. Sono contrario alla letteratura militante. Passata la milizia, muore.
Lei ha detto che, per molti disgraziati segnati dal destino, il carcere rappresenta l’ultimo “disperato aggancio al mondo dei liberi”. Non crede che un simile sforzo di comprensione meriti anche la complementare constatazione di come lo Stato abbia vergognosamente lasciato la presa in intere zone periferiche di Napoli e altre grande città, lasciando in balia della delinquenza organizzata migliaia di poveri e disperati?
Già nel ’32 il prefetto Mori, non certo sospetto di simpatie comuniste, ammoniva: se, una volta sradicata la Mafia, ai giovani non si offrono diverse opportunità, la Mafia risorgerà dalle sue ceneri.
Un’ultima domanda. I suoi progetti futuri.
Sono superstizioso. Mi avvalgo della facoltà di non rispondere.
grazie a http://www.thrillermagazine.it/ |