|
Michele Pistillo
"Doppia lealtà" o "Appartenenza":
la storia del PCI dal 1947 al 1991 |
La
pubblicazione in volume degli atti del convegno organizzato
dalla Fondazione Istituto Gramsci il 25-26 maggio 2001, sul
tema «Il PCI nell’Italia repubblicana», ci
aiuta a sviluppare alcune considerazioni sullo stato attuale
della storia del PCI, per il periodo di cui si è occupato
il convegno.
L’intento chiaramente perseguito e riproposto nella Introduzione
agli atti scritta da Giuseppe Vacca è quello di indicare
una linea interpretativa della politica e dell’opera complessiva
del più grande partito di opposizione in Italia (per
il periodo considerato), e tra i maggiori partiti comunisti
in Europa e nel resto del mondo. Quindi, la metodologia interpretativa
ha una chiara prevalenza, al punto che Vacca, riferendosi in
primo luogo alle relazioni presentate da Silvio Pons e Roberto
Gualtieri, parla di «un primo abbozzo di storia del
PCI dal 1943 al 1991» 2. In
modo molto sintetico si possono richiamare alcuni «paradigmi
» interpretativi dai quali i protagonisti del convegno
sembrano siano partiti per una storia, certamente complessa,
ma più rispondente, secondo loro, al reale svolgimento
degli eventi che hanno segnato la vita di questo partito: il
superamento dell’antinomia autonomia – eterodirezione
e dipendenza dall’esterno, cioè dall’URSS;
la nozione del «doppia lealtà - doppio Stato»,
quale punto centrale della storia del PCI; un’attenzione,
che finisce col diventare predominante, al fattore internazionale,
che agirebbe in modo «virtuoso» 3 per
la DC e i suoi governi durati cinquant’anni, «mentre
per il PCI, tranne che nel breve periodo della grande alleanza
antifascista, la “doppia lealtà” lo aveva
impedito» 4. Non a caso il
convegno si apre con la relazione di Silvio Pons, dedicata al
rapporto PCI-URSS.
Dobbiamo aggiungere, prima di svolgere alcune considerazioni
su questo modello interpretativo, che la Introduzione di Vacca,
anche alla luce delle reazioni, molte strumentali e immediatamente
politiche, è sicuramente più serena e equilibrata
rispetto alle due relazioni che hanno suscitato un vivace dibattito
nel convegno e sulla stampa.
Il volume di cui ci occupiamo non dà conto di tutti gli
interventi che si sono svolti nel convegno, alcuni apertamente
polemici con le relazioni, mentre diffuse erano le impressioni
e le considerazioni critiche in molti dei partecipanti. Ma è
su quanto è stato pubblicato che dobbiamo soffermarci,
considerandolo non solo un avvio di una discussione e di una
ricerca (è stato, il convegno, certamente anche questo),
ma anche il punto di approdo, richiamato da Vacca nella sua
Introduzione, di un lavoro durato più di un decennio
e che giunge ad alcune conclusioni significative. Non già
«un’archiviazione della storia del PCI» (che
nessuno è in grado di fare anche se lo volesse), ma una
rappresentazione di essa, la quale se fa discutere (e questo
è un bene), imprime già un segno di non poco conto,
nel senso di non pochi capovolgimenti di metodi di ricerca e
di giudizi storici, che avevano ed hanno una valenza politica
immediata (al di là, lo ripetiamo, delle ridicole e
dissennate strumentalizzazioni di certi giornali) «com’è
normale che sia - è sempre Vacca che scrive - nelle
attività di ricerca di un Istituto collegato a un partito»,
che ha alle spalle una grande tradizione di studi, di ricerca,
di organizzazione della cultura legata all’opera e al
nome di Antonio Gramsci.
Comprendiamo perfettamente il collegamento tra storiografia
e politica. L’essenziale è che quest’ultima
non pieghi alle sue esigenze la verità storica. Né
ci impressiona l’espressione «revisionismo storiografico
» se con essa si intende una ricerca più ampia,
approfondita, che rinnova certe opinioni e certi giudizi e dà
un apporto consistente alla conoscenza di un intero periodo
storico. Non può essere accolto il «revisionismo
» deteriore, il quale spesso si avvale di un documento,
facendone un feticcio, fuori dal contesto storico reale, dimenticando
o deformando fatti ed avvenimenti, senza tener conto del reale
rapporto di forze in lotta tra loro coi relativi condizionamenti
sia interni che internazionali. E soprattutto non ci piace
la storia che esclude le masse e va avanti a colpi di citazioni
(non sempre corrette) e di bibliografie, nelle quali non si
distingue quasi mai il contributo di uno studioso da quello
di un altro. Una bibliografia, vogliamo dire, andrebbe richiamata
e utilizzata con senso critico.
Doppia lealtà, doppio Stato
«Quella di “doppia lealtà” è
una categoria euristicamente ricca ma anche fortemente ambigua
e per questo si intende qui utilizzarla con estrema cautela,
in un’accezione ben delimitata e al tempo stesso assai
ampia»: così Roberto Gualtieri nella sua relazione,
che ritiene «assai discutibile» il concetto di «doppio
Stato» 5. Ma, nonostante queste
buone intenzioni e la corretta avvertenza, l’Introduzione
di Vacca e le due relazioni fanno un uso largo e costante di
questa nozione, fino a elevarlo a uno dei «paradigmi»
interpretativi della storia del PCI.
Il punto di partenza è costituito dagli studi di Franco
De Felice, che avevano un altro scopo e altre finalità.
Se abbiamo ben compreso l’ampio e complesso saggio dello
storico scomparso, Doppia lealtà e doppio Stato 6,
la sua base di riferimento è in un continuo intreccio
tra Stato legale e Stato costituito di «governi privati»,
«con una marcata affermazione dei processi societari
e la loro incidenza sul sistema di rappresentanza e sulla formazione
della decisione politica, con il lobbysmo» 7.
E per essere ancora più chiaro che si tratta di «doppio
Stato» (sempre all’interno di una singola nazione)
De Felice aggiungeva significativamente: «Nella categoria
“doppio Stato” occorre dare al termine “Stato”
il significato qualificante e specifico suo proprio, e questo
significa che interessa ed investe funzioni statali: per questa
ragione ritengo più precisa e adeguata la categoria
di doppio Stato invece di quella di governo invisibile»
8. È del tutto evidente che l’indagine
di Franco De Felice ha al suo centro lo «Stato nazionale»
nel quale interessi privati, forze economiche nazionali e straniere,
organizzazioni sovversive, strumenti mediatici, danno luogo
a un altro vero e proprio Stato, realizzando una «doppia
lealtà», finché non si arriva a momenti
di gravi contrasti e di scontri più o meno aperti e
alla sovversione.
Non è un caso che una parte importante del saggio di
Franco De Felice sia dedicato alle organizzazioni e ai tentativi
di sovvertire la legalità costituzionale, soffermandosi
ampiamente su fenomeni eversivi quali Rosa dei venti, Gladio,
P2, organizzazioni tipo Avanguardia Nazionale, Pace e Libertà,
le attività dei servizi segreti italiani inquinati e
in molti casi direttamente influenzati dalla Cia, per concludere
con la vicenda Moro 9.
A Franco De Felice era ben presente «la componente
internazionale e [che] nel “nesso nazionale-internazionale”
è individuabile la radice della funzione dirigente ed
anche del doppio Stato» 10.
Uno dei punti centrali del saggio è costituito dal valore
e dal significato dell’antifascismo, di cui i comunisti
italiani furono parte integrante e decisiva. Per Franco De Felice
l’antifascismo «è un mutamento istituzionale,
l’adozione di una forma politica di democrazia parlamentare
pluralista, accompagnata dalla definizione per grandi linee
di un progetto di riorganizzazione sociale (Costituzione per
larga parte programmatica)».
Eppur tuttavia, il punto su cui insiste l’autore del saggio
è che ben presto, e non solo per le influenze esterne,
si crea una contrapposizione tra «costituzione materiale
» e «costituzione formale», «il
contrasto cioè tra una fragile e precaria rottura democratica
e la permanenza di una struttura di comando e di gerarchie sociali
non intaccata e tendente a svuotare la rottura di significato,
rilevanza e capacità espansiva» 11.
Questo blocco di forze sociali e politiche opera anzitutto
sul terreno della continuità dello Stato italiano, nonostante
la rottura dell’antifascismo. Mentre «le gambe
che renderanno operativo tale sistema saranno, in un arco estremamente
denso e ristretto di anni, la scelta filo-occidentale (anzi
in prima istanza filostatunitense), l’apertura al mercato
internazionale, la stipulazione d’alleanze politico militari.
La strada imboccata nel 1942-1943 sarà definita nel
1949»
12.
Aggiunge ancora significativamente De Felice: «Per
quanto penetrante, per la particolarità della storia
italiana, il sistema della doppia lealtà non interessa
in misura esclusiva il nostro paese e non può considerarsi
un tratto distintivo della sua vicenda»
13.
E indica alcune particolarità della situazione italiana:
«L’Italia è l’unico grande
paese industriale europeo in cui tra maggioranza e opposizione
non esiste una convergenza sulle scelte strategiche […] la
classe dirigente in senso ampio è spaccata»
14. È facile affermare che questo
tratto che caratterizzava la situazione italiana dal 1943 al
1991 sia presente ancor oggi, con maggiore virulenza, nonostante
la scomparsa dell’URSS e del PCI. Ed è, quindi,
dal terreno nazionale che bisogna partire per comprendere appieno
il perché di questa spaccatura, dando il giusto peso
alle influenze e ai condizionamenti internazionali, che ci sono
stati sia sulla DC che sul PCI, e su altre forze politiche e
strutture più o meno segrete. Ogni altro approccio, se
da un lato schiaccia il PCI sulla presenza e i condizionamenti
dell’URSS e la DC su quelli statunitensi e «occidentali»,
ci fa smarrire il vero terreno dello scontro che è legato,
in primo luogo, anche se non esclusivamente, alla nostra storia
nazionale.
Non è un caso che Franco De Felice riprenda una parte
estremamente significativa di un articolo di Togliatti, apparso
su Rinascita, il 5 maggio 1962. «Sono vent’anni
che si combatte in Italia. Vent’anni che due forze avverse,
l’una di progresso e di rivoluzione, l’altra di
conservazione e reazione, si affrontano e misurano in un conflitto
che ha avuto le più diverse fasi, nessuna delle quali,
però, si è conclUSA in modo tale che potesse significare
il sopravvento definitivo dell’uno o dell’altro
dei contendenti […]. Quale l’origine di
questa situazione? Essa è la conseguenza di un fatto
che non può più e non potrà mai essere
cancellato. Le classi popolari sono diventate, in un momento
decisivo della storia nazionale e della vita dello Stato italiano,
protagoniste di questa vita e di questa storia […].
Da questo dato di fatto parte e sopra di esso si fonda tutta
la situazione del nostro paese» 15.
È in questo quadro complesso e fortemente condizionato
che si collocano le vicende del PCI, dello schieramento popolare
e di sinistra, dei sindacati, delle grandi masse popolari.
L’uso applicato ai collegamenti internazionali della nozione
di «doppia lealtà - doppio Stato», e la sua
riduzione alla preminenza dell’elemento esterno, finisce
con lo schiacciare la DC sugli Stati Uniti e il PCI sull’URSS.
Scompaiono l’Italia con i suoi veri problemi, le classi
dirigenti vecchie e nuove, lo scontro e l’organizzazione
delle masse, ingigantendo la dipendenza dall’esterno per
cui «l’eterodirezione» scacciata dalla porta
rientra dalla finestra e l’autonomia (condizionata, anche
se in modo né continuo né permanente) ridotta
al limite. Su questa china si arriva alla parodia della storia
di cinquant’anni della repubblica italiana.
L’appartenenza ideologica
La sottolineatura della storia e della realtà nazionale,
lo abbiamo già rilevato, non può portare ad alcuna
sottovalutazione del quadro internazionale, dei suoi condizionamenti,
dell’esistenza di due blocchi contrapposti, per il periodo
di cui ci occupiamo, delle lotte e degli schieramenti che essi
hanno indotto a livello nazionale, del peso politico, economico,
culturale oltre che militare che essi hanno avuto. Questo complesso
di fattori ha lasciato un segno profondo sul nostro paese almeno
fino al 1989, per spostarsi su di un altro terreno, con l’esistenza
di un’unica superpotenza, gli Stati Uniti d’America,
e con le nuove e più gravi minacce che questo fatto comporta.
La caduta dell’URSS ha sconvolto il mondo, così
come aveva fatto la rivoluzione d’ottobre del 1917. La
nascita e la fine dell’URSS riempiono il secolo appena
finito, dandogli un tratto essenziale da cui non si può
prescindere.
I campi contrapposti, sia prima che dopo il 1917, hanno messo
il loro sigillo sul «secolo breve» coi nazionalismi,
i fascismi, le due guerre mondiali coi relativi disastri del
dopoguerra. Si è trattato di uno scontro per la vita
e per la morte. Scrive Eric J. Hobsbawm: «Il secolo
breve è stato un’epoca di guerre religiose, anche
se le religioni più militanti e assetate di sangue sono
state le ideologie laiche affermatesi nell’Ottocento,
cioè il socialismo e il nazionalismo […] la
loro forza non era tanto consistita nella capacità di
suscitare emozioni simili a quelle delle religioni tradizionali […] Bensì nella promessa di fornire soluzioni
durature ai problemi di un mondo in crisi. Ma proprio in ciò
si è dimostrato il loro fallimento alla fine del secolo»
16.
È questa divisione del mondo che si verifica già
alcuni decenni prima della rivoluzione russa. Per questo la
nozione di «doppio Stato», così com’è
stata intesa e utilizzata da molti studiosi della storia italiana
dal dopoguerra, e ritenuta un «paradigma» per comprendere e interpretare la storia del PCI (1943- 1991), è
fuorviante e non ci aiuta a capire il secolo che è trascorso,
e tanto meno la storia del PCI e della DC (per la quale bisognerebbe
parlare di «triplice Stato e triplice lealtà»:
Stato italiano, Vaticano, Stati Uniti d’America). Se si
volesse proprio individuare un’applicazione da laboratorio
della nozione di «doppia lealtà - doppio Stato»,
secondo l’analisi di De Felice, bisognerebbe richiamare
l’assassinio del presidente americano Kennedy o la campagna
elettorale in Italia del 1948. Nel primo caso, il presidente
della più grande potenza mondiale viene ucciso, annientato
da una coalizione di interessi, quasi un altro Stato (mafia,
settori della CIA, esuli cubani, grandi centri di potere industriale,
militare, finanziario). Nel secondo caso, le elezioni politiche
del 1948, allo Stato italiano si affianca nella lotta al comunismo
lo Stato del Vaticano, che mobilita tutte le sue forze (dai
Comitati civici, alle chiese, ai parroci, fino a far girare
santi e madonne in lacrime) per sconfiggere i «cosacchi»
italiani e quelli russi, i cui cavalli si sarebbero abbeverati
nelle fontane di S. Pietro, in caso di vittoria del Fronte popolare.
Naturalmente il tutto si completa con la partecipazione massiccia
degli americani, con tutti i mezzi: dal ricatto dello «sfilatino»
alla minaccia di un intervento armato.
Altro, dunque, deve essere il «paradigma» interpretativo,
il quale se è valido fino in fondo lo è in tutte
le situazioni. Si pensi al periodo fascista: i comunisti, i
socialisti, gli antifascisti non si riconoscevano nel proprio
Stato (che è, ovviamente, cosa diversa
dalla Patria e dalla nazione); e i primi si riconoscevano,
si collegavano con lo Stato sovietico, in quanto parte di un
campo opposto all’altro (o ad altri dopo l’avvento del
fascismo e del nazismo). Queste considerazioni ci inducono a
mettere in primo piano la nozione di «appartenenza»,
sul piano ideologico e politico, e, più ampiamente,
economico, militare, culturale.
Basti pensare al fatto che ancora oggi, sepolti l’URSS
come entità statale e il PCI come partito politico, vi
è chi agita la logora bandiera dell’anticomunismo.
Nel nostro paese, in realtà, la teoria del «doppio
Stato» si incarna oggi in una sola persona, la cui lealtà
verso i propri corposi interessi è intrisa di slealtà
verso la Costituzione della Repubblica italiana.
Per questo riteniamo giusta la considerazione di Ernesto Galli
della Loggia, nel suo intervento al convegno: «Il
Partito comunista italiano era nato come una filiazione della
rivoluzione leninista ed era orgoglioso di esserlo e di riconoscersi
nell’URSS. Fare riferimenti a concetti come “nazionale”
e “internazionale” cela e occulta questo dato che
è invece storicamente decisivo: ciò che dà
coerenza al legame tra Unione Sovietica e PCI non è l’identità
delle scelte tra Togliatti e Stalin, ma il fortissimo senso
di appartenenza ideologica». Egli ha ragione
da vendere sia quando considera strumentale il binomio «autonomia
- eterodirezione», sia quando critica l’impostazione
stessa del convegno in modo molto più vivace e severo
di quel che appare oggi negli atti 17,
chiedendo di fare i conti con tutte le precedenti elaborazioni
che riguardavano in primo luogo Togliatti e la tradizione comunista
in Italia. Naturalmente Galli della Loggia, fa finta di non
ricordare che per decenni il PCI era stato presentato e combattuto
come «servo di Mosca», «la lunga mano di Mosca»,
e che nelle elezioni del 1948 il volto di Garibaldi diventava,
capovolto, quello di Stalin.
Se è vero che nessuno studioso serio ha mai scritto di
un PCI «eterodiretto» (Victor Zaslavsky e Aga Rossi,
sull’onda avviata da Renzo De Felice, fanno eccezione),
è anche vero che una delle motivazioni per escludere
il PCI dal governo del paese fu proprio l’accUSA della
sua «dipendenza» da Mosca (il fattore K).
L’appartenenza, dunque, ad un campo, ad uno schieramento,
ad una ideologia: questo è uno dei punti nodali della
storia del PCI, di tutta la sua storia. La guerra fredda del
secondo dopoguerra proseguiva lo scontro, in altre forme e con
altri mezzi, che già era in atto prima della seconda
guerra mondiale, durante la costruzione dell’URSS, prima
della stessa costruzione dell’URSS. Il «mito del
socialismo» che si diffonde già nella seconda metà
dell’Ottocento, si fonda e diventa tutt’uno con
il «mito dell’Unione Sovietica».
L’internazionalismo proletario nasce prima dell’URSS
e se proprio vogliamo andare alle origini, nasce col Manifesto
di Marx e di Engels nel 1848.

La «doppiezza» togliattiana
Ciò che colpisce nella relazione di Silvio Pons (L’URSS
e il PCI un sistema internazionale della guerra fredda)
è la linea secondo la quale la storia del PCI è
in gran parte nel rapporto con l’URSS e, quindi, negli
archivi di Mosca. Noi la pensiamo in modo diametralmente opposto.
Questi archivi se ben utilizzati (senza forzature e strumentalizzazioni)
ci possono aiutare a capire non poche cose. Ma il punto è
che questa storia è da ricercare nelle vicende italiane,
in primo luogo: nello scontro politico, sociale, culturale,
di classe che nel nostro paese si è sviluppato, nelle
caratteristiche peculiari del PCI, della DC, dei sindacati,
di grandi organizzazioni di massa; nella presenza massiccia,
pesante, condizionante, degli americani almeno fino a tutti
gli anni settanta.
Silvio Pons, direttore della Fondazione Istituto Gramsci, giunge
ad affermare, ed è affermazione non suffragata da nessuna
documentazione seria, che «è evidente l’ambivalenza
della condotta togliattiana: l’opzione legalitaria non
era mai stata enunciata come una scelta di principio dallo stesso
Togliatti, che anzi in varie occasioni, aveva lasciato aperta
l’opzione insurrezionale» 18.
Tutta la documentazione raccolta e analizzata da Giuseppe Vacca
già nel suo Saggio su Togliatti e la tradizione comunista
negli anni settanta andava in direzione diametralmente opposta.
Il quinto capitolo del volume, dedicato a «rivoluzione
antifascista e transizione al socialismo in Italia 1944-1947»,
si apriva con il seguente giudizio di Togliatti: «Si
dice spesso che, dopo la liberazione, l’occupazione straniera
del territorio nazionale, che rendeva militarmente impossibile
la vittoria di una insurrezione popolare, fu il fattore determinante
della politica dei comunisti […] La nostra politica
fu in realtà ispirata e dettata da motivi ben più
profondi - dichiarava Togliatti in apertura del Rapporto
al X Congresso del partito, che ha i caratteri del bilancio
d’una esperienza politica e di lotta ormai ventennale
- Si era creata, nella Resistenza, una unità di forze
democratiche che si estendeva fino a comprendere, socialmente,
gruppi di media borghesia progressiva e, politicamente, una
grande parte del movimento cattolico di massa. Noi eravamo stati
in prima fila tra i promotori, organizzatori e dirigenti di
questa unità, che possedeva un suo programma di rinnovamento
di tutta la vita del paese, un programma che non venne formulato
in tavole scritte se non parzialmente, ma era orientato verso
la instaurazione di un regime di democrazia politica avanzata,
riforme profonde di tutto l’ordinamento economico e sociale
e l’avvento alla direzione della società di un
nuovo blocco di forze progressive. La nostra politica consistette
nel lottare in modo aperto e coerente per questa soluzione,
la quale comportava uno sviluppo democratico e un rinnovamento
sociale orientati nella direzione del socialismo.
Non è dunque che noi dovessimo fare una scelta tra la
via di una insurrezione legata alla prospettiva di una sconfitta,
e una via di evoluzione tranquilla, priva di asprezze e di
rischi.
La via aperta davanti a noi era una sola, dettata dalle circostanze
oggettive, dalle vittorie riportate combattendo e dai programmi
sorti nella lotta. Si trattava di guidare e spingere avanti,
sforzandosi di superare e spezzare tutti gli ostacoli e le
resistenze, un movimento reale di massa, che usciva vittorioso
dalle prove di una guerra civile. Questo era il compito più rivoluzionario
che allora si ponesse, e per adempierlo concentrammo le forze.
L’occupazione militare del territorio nazionale e l’intervento
straniero nelle cose nostre, non agirono come freno di velleità
insurrezionali che non esistevano, ma come elemento di organizzazione
e direzione dell’opposizione conservatrice e reazionaria
che riuscì, a un certo punto, a interrompere il processo
di rinnovamento già iniziato» 19.
Togliatti non ha mai nascosto che il fine ultimo del PCI e
delle forze ad esso alleate fosse quello del socialismo nel
nostro paese. Ma già col VII Congresso dell’Internazionale
comunista era cambiata «la strategia»: «I comunisti si schieravano a difesa del regime democratico […] prendevano nelle loro mani la bandiera della
democrazia […] L’indirizzo non era dunque
più soltanto di tattica, ma di strategia».
E ancora: «Ciò che noi facciamo è, nelle
condizioni di guerra, di catastrofe nazionale e di pericolo
di rinascita fascista, un’applicazione originale e nostra
di quella proposta di creare dei governi di fronte nazionale
antifascista che venne avanzata nelle file del movimento comunista
fin dal 1935» 20. A proposito
di questa linea strategica commenta Vacca: «È questa
la strategia con la quale, nella situazione storica data, la
classe operaia afferma e fa avanzare la propria propostadi
ricomposizione unitaria delle forze produttive esauste e delle
masse rovinate dalla guerra […] questa è una
strategia nazionale e di classe al tempo stesso» 21.
Potremmo continuare nelle citazioni. Particolarmente nel 1956,
sia nelle sue relazioni al Comitato centrale, sia in quella
all’VIII Congresso, nella Dichiarazione programmatica,
il carattere strategico della «via italiana al socialismo»
è continuamente sottolineato da Togliatti.
Vi è un discorso, particolarmente significativo perché
ci consente di affrontare un altro dei temi presenti nelle due
relazioni al convegno dell’Istituto Gramsci, che Togliatti
pronuncia il 10 giugno 1948 e, quindi, all’indomani della
sconfitta elettorale del Fronte popolare del 18 aprile, alla
Camera dei deputati.
«Quando un partito comunista ritiene che le circostanze
oggettive e soggettive pongano all’ordine del giorno la
necessità per le forze popolari avanzate di prendere
il potere con le armi, cioè con una insurrezione, esso
proclama questa necessità, lo dice apertamente. Così
fecero i bolscevichi nel 1917, e marciarono all’insurrezione
a bandiere spiegate. Così abbiamo fatto noi, comunisti
italiani, a partire dal settembre 1943.
Non abbiamo nascosto a nessuno che la via che avevamo preso
e proponevamo al popolo era la via dell’insurrezione;
insieme con i compagni socialisti e con gli amici di “giustizia
e libertà” abbiamo marciato su questa via senza
esitazioni e abbiamo vinto contro il fascismo e contro l’invasore
straniero [...] E noi, comunisti italiani, quanti depositi
di armi credete che avessimo sotto il fascismo? Nemmeno uno!
E quanti ne avevate voi socialisti? Nemmeno uno anche voi.
Ma quando vi è stato bisogno di spezzare con le armi
la tracotanza dei tedeschi e il tradimento dei fascisti, le
armi ci sono state e sono state vittoriose » 22.
E, ancora, a proposito delle armi nascoste, sempre nello stesso
discorso, Togliatti affermava: «Nel corso del 1947
vi furono persino i primi segni di un risorgente squadrismo,
che manifestò con gli attentati a ripetizione contro
le sedi dei partiti popolari e dei sindacati. A un certo punto
ci si accorse però che la via era, e rimane, molto pericolosa
e per parecchi motivi.
Si diceva, si sussurrava infatti da tutte le parti che molte
armi erano nascoste, e sarebbero venute fuori alla luce del
giorno in cui un qualsiasi tentativo di ripresa fascista ci
fosse stato.
Benedette le armi nascoste, dunque, se hanno salvato la nostra
patria da un’altra sciagura di quel genere, da un’avventura
la quale avrebbe potuto portarci ancora più in basso!
Benedette le armi nascoste! Per questi motivi credo non sia
ancora, oggi, la vostra ora, onorevoli colleghi del Movimento
sociale italiano; ed è per questo che voi date su quei
banchi la lamentevole impressione di relitti, spettri di un
passato d’infamia e di vergogna» 23.
Ci siamo soffermati su questo punto, perché quello della
«doppiezza» nella linea del PCI è questione
che divide profondamente gli storici. Non voler prendere atto
della realtà degli avvenimenti non aiuta a comprendere
molte cose, tra le quali il fatto indiscutibile della grande
influenza politica, elettorale, culturale di quello che, a ragione,
è stato definito «il più grande partito
comunista d’Occidente». Né si modifica questa
realtà dando credito all’opzione armata, secondo
alcuni, sempre presente nella linea del PCI.
Sappiamo bene che non pochi hanno considerato l’insurrezione
vittoriosa del 25 aprile 1945, l’inizio di una più
vasta rivoluzione, sul tipo di quella che si svolgeva in Jugoslavia.
Ma l’opera svolta da molti comandanti partigiani comunisti,
non solo ai più alti livelli, secondo le precise direttive
del PCI, raffreddò gli animi di molti combattenti, servì
a chiarire, a spiegare, ad orientare. Certamente in quei giorni
e nelle settimane successive, alla cacciata dei tedeschi e alla
fine della Repubblica di Salò, ci furono violenze, da
parte partigiana, che in non pochi casi andarono oltre il limite.
Vendette operate da gruppi che agivano liberamente al di fuori
di ogni disciplina, una sacrosanta collera («i giorni
dell’ira») contro gli autori di massacri, soprusi,
violenze contro le popolazioni e i partigiani. Si voleva sradicare
il fascismo alle radici, si faceva però non solo giustizia
sommaria di alcuni capi (e questo rientrava nelle direttive
del CLN Alta Italia), ma anche di tanti, uomini e donne, che
avevano collaborato o direttamente combattuto con la Rsi e con
i tedeschi. Purtroppo, in alcune zone le violenze continuarono
anche nelle settimane e nei mesi successivi all’aprile
1945, gettando sul movimento partigiano un’ombra oscura,
che non si riuscì ad evitare, quando non fu apertamente
incoraggiata a livello locale (si pensi all’Emilia e al
«triangolo della morte»).
L’epilogo dell’aprile 1945, se aprì una pagina
nuova nella storia d’Italia, scavò, pure, un fossato
rimasto per decenni incolmabile e che nessuna «retorica
resistenziale » può far ignorare. In quei giorni
e in quelle settimane furono nascoste molte armi, in molte
zone.
Lo fecero gruppi di partigiani comunisti; ma anche socialisti,
azionisti, e quasi certamente non pochi seguaci della Rsi. Una
delle ultime trovate del gerarca Pavolini, mentre tutto crollava,
fu quella di nascondere armi da utilizzare contro gli americani,
in una improbabile guerriglia che si riteneva di poter organizzare.
Si tenga presente un altro dato importante. All’indomani
dell’esclusione dei comunisti e dei socialisti dal governo,
Togliatti dichiara alla Direzione del suo partito: «occorre
impedire che il partito e le masse che ci seguono scivolino
su posizioni che conducono alla lotta e alla insurrezione armata»
24. E al quesito posto da Togliatti
all’ambasciatore
Kostilev («se si deve nel corso di una o più provocazioni
da parte dei democristiani e di altri reazionari, iniziare l’insurrezione
armata delle forze del fronte democratico popolare per prendere
il potere») la risposta di Mosca (vivo Stalin) è
assolutamente negativa. Era esattamente ciò che Togliatti
voleva: con il consenso di Stalin egli intendeva troncare ogni
discussione nella Direzione del PCI su questa eventualità.
Non è la prima volta, del resto, che egli utilizzava
questa via per difendere la sua linea, che avanzava a fatica
nel partito.
L’aveva già fatto per la «svolta di Salerno»,
lo farà ancora con la missione Secchia a Mosca e con
la nota risposta di Stalin di sostegno alla sua linea.
Roberto Gualtieri, rifacendosi ad alcuni contributi e a documenti
di scarsissima attendibilità (egli stesso definisce «maldestro»
il modo di utilizzare la documentazione dell’Archivio
di Stato da parte di Gianni Donno, La Gladio rossa del PCI
1945-1967) 25, cerca di avvalorare
la tesi, con prove «sia pure solo indirette», dell’esistenza
di una «struttura spionistico-militare illegale legata
all’Unione Sovietica», che impedirebbe «di
leggere la storia del PCI sulla base della categoria dell’“autonomia”,
prescindendo dalla realtà dei suoi legami internazionali».
Cioè la sua «dipendenza da Mosca».
Ovviamente Gualtieri fa ampio uso della tesi dei finanziamenti
sovietici al PCI, ma non tralascia «lo spionaggio, il
sabotaggio, la raccolta di informazioni», sempre riferendosi
a contributi e alla documentazione «indiretta» di
altri, gran parte della quale è stata raccolta nelle
Questure dell’epoca scelbiana e da false note informative
scritte da infiltrati della polizia nelle sezioni e nelle federazioni
del PCI.
I soldi di Mosca ci sono stati, e fino alla fine degli anni
settanta furono anche molti. Ma erano certo minori dei finanziamenti
americani, che arrivarono alla DC dagli USA, ai sindacati come
la Cisl e la Uil, ad altri partiti della coalizione governativa,
alle organizzazioni clandestine e di provocazione contro il
PCI e la sinistra («la strategia della tensione»).
Per non parlare dei finanziamenti di grandi industrie, a incominciare
da quelle di Stato.
Cossiga ha recentemente dichiarato (l’Unità,
15 febbraio 2003) che «la DC aveva mantenuto una propria,
per quanto labile, struttura militare, parallela a quella comunista,
che fu sciolta nel 1954 dal comitato militare guidato da Taviani».
La DC aveva, dunque, una sua struttura militare (per quanto
«labile») nonostante avesse a sua disposizione il
governo, le forze di polizia, l’esercito (sicuramente
gli alti comandi), le forze armate americane e le loro basi,
i servizi segreti. Maurizio Caprara affronta il tema di un PCI
«proiettato all’offensiva della rivoluzione»,
per concludere che «la superba potenza attribuita
da alcuni avversari a un esercito rosso è un mito approssimativo,
se non altro frutto di approssimazione, un meccanismo di difesa
afflosciato, in parte smantellato e in parte arrugginito perché
inattivo da anni» 26.
Mentre Cossiga ha dichiarato alla Commissione Stragi del Parlamento:
«Quando mi sono chiesto per quale motivo il Partito
comunista non si sia impadronito del potere con la forza […] la
spiegazione è stata sola una: la scelta
irrevocabilmente democratica e parlamentare fatta da Togliatti
e la divisione del mondo in due. Lo Stato italiano non sarebbe
stato assolutamente in grado di impedire una presa del potere
per infiltrazione o per violenza da parte del Partito comunista.
Di questo non ho dubbio alcuno. Ecco il motivo del mio giudizio
di democraticità sul Partito comunista: perché
il Partito comunista non ha fatto quello che avrebbe potuto
facilmente fare. E non lo ha fatto per due motivi: perché
Mosca non glielo avrebbe permesso, anzi li avrebbe mollati,
e in secondo luogo perché la scelta democratica e parlamentare
di Togliatti (la “via nuova”) era irrevocabile»
27.
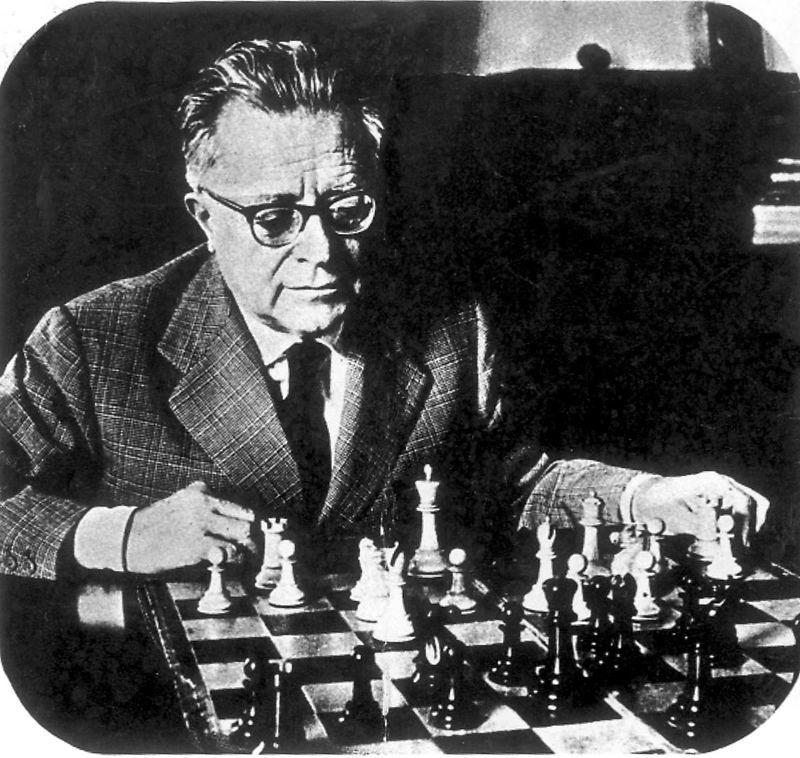
Ciò che manca nelle due relazioni al convegno, specie
in quella di Gualtieri, è una robusta e realistica analisi
della «guerra fredda», con tutto ciò che
essa ha significato soprattutto in Italia (paese di confine
fra gli opposti campi, con la presenza dello Stato del Vaticano,
degli americani, di un forte e radicato partito di governo,
la DC, per più di 45 anni e del più forte e radicato
partito comunista dell’Europa occidentale).
L’Italia diventa così un paese laboratorio, di
scontro diretto, dove la lotta politica, sociale, culturale,
quella estera e militare aveva una profondità, una continuità,
ed una partecipazione di massa sconosciute in altri paesi occidentali.
In Italia, e solo da noi, nonostante l’armatissima, numerosissima
armata del PCI (Victor Zaslasky, tutto dominato dal suo anti-comunismo
viscerale, riferisce di non meno di 100-150mila uomini armati,
ben diretti) è stato realizzato un attentato al capo
dell’opposizione che poteva portare – ma non avvenne
innanzitutto per precise indicazioni di Togliatti – a
una guerra civile. Ci fu lo sciopero generale in gran parte
spontaneo. Ci furono grandi manifestazioni di massa, scontri
in alcune città, soprattutto al nord con la polizia.
Ma tutto rientrò nell’alveo dello scontro democratico.
Non per nulla l’incaricato del PCI e della CGIL di trattare
con De Gasperi fu Giuseppe Di Vittorio, il quale a tutto pensava
meno che ad una insurrezione.
Giuseppe Vacca (l’Unità del 9 novembre
1991), in una nota dal titolo significativo, 1954, Mario
Scelba «questuante» in USA, ha scritto: «La
guerra fredda è stata l’origine dei “disastri”
in cui da molti anni abbiamo visto cadere il mondo. Oggi siamo
in grado di vedere meglio come, nel lemma guerra fredda, l’accento
debba essere posto più sul sostantivo che sull’aggettivo».
Poi passa a parlare dei finanziamenti americani sulla base
delle testimonianze di Egidio Ortona, ambasciatore italiano
in USA 28. Così riferisce Ortona
su alcuni incontri avuti con Scelba: «L’ambasciatrice
Luce […] mi aveva anche detto che se si fosse
condotta una lotta anticomunista vigorosa, si sarebbero avuti
aiuti speciali. La lotta si è fatta ma gli aiuti non
sono venuti». Il 30 marzo 1954 si sono già
svolte le elezioni alla Fiat. La CGIL ha subìto una
dura sconfitta. «Alla notizia (presente Scelba) -
annota Ortona - vedo mrs Luce perdere per la prima volta
il controllo abituale e quasi fare un balzo di gioia sulla sedia […] Il giorno dopo al Dipartimento mi si fa osservare
che, bene o male, tra le varie voci, il nostro premier si porta
a casa circa duecento milioni di dollari».
Non vi è bisogno di ricordare che Mario Scelba è
stato per diversi anni ministro degli Interni. Il 9 gennaio
1950, davanti alle Fonderie riunite di Modena, la polizia sparava
sui lavoratori che si erano riuniti per la chiusura di un’altra
fabbrica, la Waldevit: cinque morti e più di cinquanta
feriti. In un solo anno la violenza antioperaia aveva provocato
una lunga catena di morti, di feriti, di arrestati: 17 lavoratori
uccisi, centinaia di feriti, 14.573 arrestati (tra i quali
77 Segretari di Camera del Lavoro, 375 dirigenti sindacali
e di leghe), 13.793 denunciati a piede libero 29.
E prima di Modena, i nostri morti nelle lotte per la terra,
il lavoro, il pane, contro la chiusura delle fabbriche, a Melissa,
Montescaglioso, Torremaggiore, Celano e parecchi anni dopo ancora
morti a Reggio Emilia.
Questa è parte integrante della storia del PCI e del
nostro paese. Nessuno ricorda oggi tutto ciò, la «verità»
deve essere cercata sopratutto a Mosca. Mentre il legame della
DC con gli USA apre un «circolo virtuoso », secondo
Vacca; per il PCI, una «duplice assenza di autonomia»
dello stesso partito: dipendente da Mosca ed egemonizzato dalla
DC, sempre secondo Gualtieri 30.
Ancora alcune rapide considerazioni sulla «duplice
assenza di autonomia» del PCI
Il rapporto tra il PCI e la DC (altrettanto si può dire
tra DC e USA e Vaticano, come tra PCI e URSS) non è stato
né facile, né semplice. Erano entrambi grandi
partiti di massa, radicati nella società, con una notevole
influenza culturale. Lo scontro non ha mai eliminato l’incontro
e il compromesso, anche nei momenti più difficili e complicati,
così come nessuno dei due è riuscito a «egemonizzare»
l’altro. Erano entrambi abbastanza autonomi e condizionati
dai ceti, dalle masse popolari, dai sentimenti di milioni di
persone di cui sapevano tener conto. Questa è stata la
loro forza. Altrettanto dicasi a livello internazionale, con
gli indispensabili condizionamenti che pesavano su di loro,
senza mai rinunciare a margini, più o meno grandi, di
autonomia. E tutto ciò avveniva nel quadro terribile
della guerra fredda, combattuta senza esclusione di colpi (Ha
scritto Vacca: «Dopo la seconda guerra mondiale,
con la costituzione dei blocchi la sovranità nazionale subì
il colpo definitivo. Tutti gli Stati nazionali posti in condizione
- chi più chi meno - di sovranità limitata. Ma
come si può sostenere che in una tale situazione, la
quale proiettava i contrasti fra le classi a scala planetaria,
all’interno di ciascun paese si potesse instaurare una
visione univoca dell’“interesse nazionale”?
[…] La guerra fredda creò una sorta di totalitarismo
planetario» (l’Unità, 26 ottobre
1991). Il quadro complessivo della guerra fredda è determinante
per ogni approccio alla storia del PCI (come della DC) e questo
quadro manca, nella sua sostanza, nelle due relazioni al convegno
(si pensi alla grave sottovalutazione di tutta la vicenda Moro,
prima e durante la prigionia e dopo il suo assassinio).
Per questo non condividiamo il giudizio di Gualtieri sulla «duplice
assenza di autonomia» da parte del PCI.
Qualche esempio ci aiuta a capire meglio la situazione.
La «svolta di Salerno», quali che siano state le
sue origini, esprime una precisa «egemonia» (proprio
nel senso gramsciano del termine) del PCI su tutti gli altri
schieramenti politici, a incominciare dalla DC. Non solo. Ma
si impone subito come una grande linea strategica per tutti
gli sviluppi futuri della storia repubblicana italiana. Vi è
in tutte e due le relazioni (il condizionamento del fatto che
essa fosse più opera di Stalin che di Togliatti) una
vera e propria sottovalutazione del carattere strategico di
quella linea.
Sull’importanza e del significato del Patto di Roma, per
la costruzione di un sindacato unitario (non unico, ma indipendente
dai padroni, dai partiti, dallo Stato) non si spende una parola
nella relazione di Gualtieri. Il sindacato, con la fortissima
presenza comunista, semplicemente non esiste. Eppure «l’egemonia
» in questo caso è stata espressa dalla parte decisiva
che il PCI vi ha avuto attraverso la figura e l’opera
di Giuseppe Di Vittorio. Un’unica organizzazione sindacale
era un tale fatto nuovo in Italia, la cui esperienza non è
andata smarrita neppure dopo le varie scissioni, finanziate
con fiumi di dollari dagli americani 31.
L’influenza che il sindacato unitario (milioni di iscritti
dopo la liberazione del Nord, mentre si creava nel Mezzogiorno
una grande struttura popolare e democratica) ha avuto nel rafforzamento
del PCI, sul suo radicamento nella società italiana un
effetto enorme e non si fa la storia dei comunisti italiani
dimenticandosi di parlarne. Possiamo ricordare le parole della
relazione informativa che Giuseppe Di Vittorio svolge alla Sezione
di informazione internazionale del Comitato centrale della VKP(b),
il 16 agosto 1945: «l’autorevolezza del nostro
partito cresce grazie alla presenza della Confederazione generale
del Lavoro, creata su iniziativa del nostro partito, nel quale
contiamo il più alto numero dei nostri sostenitori»
32.
È impossibile sottovalutare la presenza, l’influenza,
il contributo di sangue dato dai comunisti nella Resistenza.
Questa non è stata egemonizzata da nessun partito. Ma
è certo che senza i comunisti non ci sarebbe stata,
o non sarebbe stata quella Resistenza.
Dov’è, qui, la «duplice assenza di autonomia»
del PCI?
Inoltre, nella vittoria elettorale e pacifica della Repubblica,
nessuno può sottovalutare il contributo autonomo e decisivo
dei comunisti alleati ai socialisti e a non pochi cattolici.
La DC nella sua maggioranza era per la monarchia, e molti sacerdoti,
con l’apparato della Chiesa cattolica, si sono spesi perché
quest’ultima prevalesse. Qui non c’è l’egemonia
della DC, e quanto alla sua autonomia, ci sarebbe parecchio
da dire.
Per tre anni i comunisti sono stati al governo del paese con
gli altri partiti antifascisti. Si operò in condizioni
terribili, tra mille difficoltà e condizionamenti (e
qui l’URSS non c’entra per niente) e compromessi.
La rottura del maggio-giugno 1947, voluta fortemente dagli
americani, dal Vaticano, da gruppi potenti della grande industria
e della finanza, non impedì si giungesse a quel «grande
compromesso storico» che fu la Costituzione della Repubblica
italiana, che è la nostra legge fondamentale da più
di cinquant’anni.
Si può parlare di mancanza di autonomia, di «egemonia»
della DC nei confronti del PCI?
Gualtieri, nella sua relazione, condizionato dalla nozione,
riferita al PCI, di «integrazione negativa», di
cui francamente ci sfugge il significato, non spende una parola
sul grande fatto storico delle lotte che si svolsero tra il
1947 e il 1951 nelle campagne, nel Mezzogiorno, che costarono
sangue e che portarono a una prima seppur limitata riforma agraria.
Il latifondo tipico fu liquidato. Questo evento, di un’importanza
eccezionale sul piano politico, sociale, culturale, è
semplicemente dimenticato. Ebbene, anche in questo caso il PCI
fu in prima fila, «egemone» e «autonomo ».
Le lotte per la terra hanno segnato nel profondo la vita del
nostro paese, e spianato la strada alla vittoria del 7 giugno
1953, quando il disegno della DC fu sconfitto.
Parlare di «integrazione negativa» per un grande
partito di massa, con milioni di iscritti e diversi milioni
di voti è un non senso. L’espressione «integrazione
» non si addice ad un grande partito (al massimo si può
parlarne per piccole «etnie», gruppi minoritari)
che affonda le sue radici nelle viscere della nostra storia,
tra grandi masse. Non, dunque, un soggetto che si «integra»
dal di fuori, ma che nasce, sorge da esse, con esse e per esse.
Il PCI sorge nelle fabbriche occupate della Fiat nel 1920; nasce
ad iniziativa degli operai, comunisti e non; nasce dai contadini
e fra i contadini; nasce fra un grande numero di intellettuali
che vogliono il socialismo e lottano o muoiono in carcere, o
in Spagna, per realizzarlo. Il PCI è classe, è
massa, è popolo, è storia diretta e visibile,
non ha bisogno di «integrarsi». Esso si espande,
conquista un numero sempre più grande di lavoratori
e di aderenti.
Diffonde le grandi idee di Gramsci attraverso un’operazione
di vastissimo respiro culturale che non ha eguali nella nostra
storia, tra la diffidenza del partito comunista sovietico e
di quelli di altri paesi. Tutto questo fa del PCI, con le sue
luci e le sue ombre, i suoi aspetti positivi e negativi, quando
avanza e quando s’arresta o indietreggia, un fatto positivo
nella nostra storia nazionale, la cui eredità non è
completamente scomparsa neppure oggi.
Un’ultima considerazione. Nel 1951 Togliatti dice no a
Stalin, respingendo la proposta di lasciare l’Italia per
dirigere il Cominform. Il tema è presente soprattutto
nella relazione di Pons. Ma in nessuna delle due relazioni
si traggono le dovute conseguenze, sul piano politico e strategico
della linea del PCI.
Togliatti dice no a Stalin almeno sui seguenti punti: - no
a un unico centro di direzione e di coordinamento dei partiti
comunisti. Sarebbe stato un ritorno al passato, dichiarato
superato nel 1943; - no a una prospettiva di guerra generalizzata,
anche se era in corso quella di Corea. Di qui la ricerca del
dialogo coi cattolici contro la distruzione dell’umanità;
- no a ogni strategia di abbandono di una prospettiva democratica
e di lotta per la pace.
Non furono questi gli argomenti espliciti che Togliatti adoperò
nella lettera a Stalin del «gennaio 1951» 33.
Egli non voleva aprire un contrasto politico grave. Ma questo
è il senso vero di quella lettera.
Dov’è la «mancanza di autonomia» del
PCI? Nella storia vera e complessa del PCI e della DC l’anno
successivo ci fu un altro no significativo: quello
di De Gasperi al Vaticano, nelle elezioni a Roma. Don Sturzo
voleva un’alleanza della DC con il Msi e i monarchici.
De Gasperi disse no e l’ebbe vinta. Sono due storie parallele,
contrapposte talvolta e anche duramente, che si incontrano e
procedono d’intesa in altri momenti, senza vincitori né
vinti, ma entrambi collegati e profondamente coinvolti e segnati
dal «totalitarismo della guerra fredda».
Vogliamo concludere con il richiamo severo che Gramsci rivolgeva
a coloro che si occupavano o si dovevano occupare della storia
«del passato, specialmente del passato più prossimo»:
«quale deve essere l’atteggiamento di un gruppo
politico innovatore verso il passato, specialmente verso il
passato più prossimo? […] L’atteggiamento
sarà tanto più “imparziale”, cioè
storicamente “obiettivo” quanto più elevato
sarà il livello culturale e sviluppato lo spirito critico,
il senso delle distinzioni. Si condanna in blocco il passato
quando non si riesce a differenziarsene, o almeno le differenziazioni
sono di carattere secondario e si esauriscono quindi nell’entusiasmo
declamatorio. È certo d’altronde che nel passato
si può trovare tutto quello che si vuole, manipolando
le prospettive e l’ordine delle grandezze e dei valori»
34. È un insegnamento valido
ancora oggi.
(da Critica
Marxista, 2003)
1)
Il PCI nell’Italia repubblicana 1943-1991, a
cura di Roberto Gualtieri, Prefazione di Giuseppe Vacca, Roma,
Carocci, 2001.
2) Ivi, p. XX.
3) Ivi, p. XIX.
4) Ivi, p. XIX.
5) Ivi, pp. 48-49.
6) Franco De Felice, Doppia lealtà e doppio Stato,
in Studi storici, 1989, n. 3; ora in id., La questione
della nazione repubblicana, con introduzione di Leonardo
Paggi, Roma-Bari, Laterza, 1999.
7) Ivi, p. 508.
8) Ibidem.
9) Vedi di Giuseppe De Lutiis, Il lato oscuro del Potere.
Associazioni politiche e strutture paramilitari segrete dal
1946 ad oggi, Roma, Editori Riuniti, 1996.
10) Franco De Felice, op. cit. p. 509.
11) Ivi, p. 513.
12) Ivi, p.515.
13) Ivi, p. 515.
14) Ivi, p. 516.
15) Ivi, p. 514. 16) Eric J. Hobsbawm, Il secolo breve,
Milano, Rizzoli, 1994, p. 516.
17) Galli della Loggia chiese, rivolto al gruppo dirigente
dell’Istituto
Gramsci, «Ma dove volete arrivare?». Mentre si legge
oggi: «Mi sembra che la revisione della vicenda del PCI
nella storia dell’Italia repubblicana si stia spingendo
molto avanti. Forse persino troppo...» (Ernesto Galli
della Loggia [Intervento], in Il PCI nell’Italia
repubblicana,
cit., p. 337).
18) Ivi, p. 20.
19) Palmiro Togliatti, Per andare verso il socialismo nella
democrazia e nella pace, rapporto al X Congresso del PCI (dicembre
1962), citato in Giuseppe Vacca, Saggio su Togliatti
e la tradizione comunista, Bari, De Donato, 1974, pp. 263-264.
20) Palmiro Togliatti, Problemi del movimento operaio internazionale,
cit. in Giuseppe Vacca, Saggio su Togliatti..., cit.,
p. 354.
21) Giuseppe Vacca, Saggio su Togliatti..., cit., p.
272.
22) Palmiro Togliatti, Discorsi parlamentari, Roma,
Camera dei Deputati, 1984, p. 306.
23) Ivi, p. 304.
24) N. Narinsky, Stalin, Togliatti e Thorez, relazione
al convegno «L’altra faccia della luna: le relazioni
tra l’Unione Sovietica e i partiti comunisti francese
e italiano», Roma-L’Aquila, maggio 1995, pp. 233-234
sgg. Questa relazione è stata ripresa in più punti
da Elena Aga Rossi e Victor Zaslasky in Togliatti e Stalin,
Bologna, Il Mulino, 1997, p. 228.
25) Roberto Gualtieri, Il PCI, la DC e il «vincolo
esterno». Una proposta di periodizzazione, in Il
PCI nell’Italia repubblicana, cit., pp. 64-65.
26) Victor Zaslavsky, L’apparato paramilitare comunista
nell’Italia del dopoguerra (1945-’55), relazione
per la Commissione Stragi del Parlamento italiano, p. 90.
27) Ivi, p. 108.
28) Egidio Ortona, Anni d’America. La diplomazia
1953-1961,
Bologna, Il Mulino, 1984, pp. 121-128.
29) Da Melissa a Modena, Roma, 1950, p. 79.
30) Roberto Gualtieri, op. cit., p. 99.
31) Roberto Faenza e Marco Fini, Gli americani in Italia,
Milano, Feltrinelli, 1976, pp. 293 sgg.
32) Dagli Archivi di Mosca. L’URSS, il Cominform,
e il PCI (1943-1951), a cura di Francesca Gori e Silvio
Pons, Roma, Carocci, 1998, p. 258.
33) Ivi, pp. 417-420.
34) Antonio Gramsci, Quaderni del carcere, edizione
critica a cura di Valentino Gerratana, Torino, Einaudi, 1975,
pp. 341-342.