|
Piergiorgio Odifreddi
Il computer di Dio
Cortina,
2000, € 15,50 |
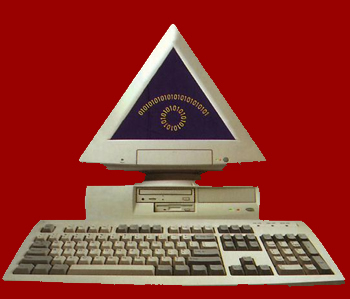
Nella "Prefazione" si precisa che i
saggi raccolti in questo libro intendono presentare in maniera
"programmaticamente divulgativa e augurabilmente piacevole"
alcuni aspetti culturali della matematica. Si tratta esattamente
di articoli, alcuni inediti e altri già pubblicati in varie
sezioni de La Stampa, tra il 21 agosto 1995 e il 16 febbraio
2000, articoli in cui si scoprono interessanti connessioni tra
la matematica e ogni altro campo della conoscenza umana, dall'attualità
alla politica, alla religione, alla filosofia, alla pittura, alla
musica...
P. Odifreddi, ottimo osservatore, sottolinea che il logo in copertina
accanto al nome dell'editore è una spirale logaritmica
e conclude la sua premessa con le seguenti parole: "Questa
curva, che Jacob Bernoulli descriveva con il motto "eadem
mutata resurgo", (risorgo uguale eppur diversa), è
un simbolo della buona divulgazione. Mi auguro che il libro sia
all'altezza del simbolo, e spero che leggerlo diverta il lettore
quanto scriverlo ha divertito l'autore."
In "La commedia degli equivoci" viene trattato
l'argomento inerente alle due culture: umanistica e scientifica:
"Umanisti e scienziati hanno il reciproco diritto di
richiedere, così come il reciproco dovere di dare, alle
altrui discipline, lo stesso sforzo di comprensione che essi dedicano
alle proprie, la stessa padronanza di linguaggio e di metodo,
la stessa considerazione per i risultati, lo stesso rispetto per
i massimi esponenti.[...] L'impresa è
possibile, come dimostrano i numerosi casi di intellettuali che
hanno saputo combinare umanesimo e scienza in una sintesi globale.
Per citare nomi a caso del Novecento: Bertrand Russell, matematico
e premio Nobel per la letteratura, Wolfgang Pauli, premio Nobel
per la fisica, e autore di un libro con Jung sulla sincronicità
[...], Francisco Varela, biologo e autore di libri col Dalai
Lama sulla coscienza."
In realtà, le due culture non sono altro che le espressioni
dei due emisferi cerebrali: del sinistro la scienza, del destro
l'umanesimo. Volerle tenere separate, o asserire la predominanza
di una di esse sull'altra, significa essere a favore della lobotomizzazione
culturale. L'atteggiamento corretto è invece considerarle
"entrambe necessarie, ma nessuna sufficiente"
per la descrizione della realtà e lo sviluppo della conoscenza:
asserirne cioè una "complementarità"
che non è solo un vuoto slogan, poiché ne implica,
in particolare, la necessità di integrazione reciproca.
Odifreddi conclude l'articolo sottolinenado che "...il
ruolo culturale del corpo calloso che collega i due emisferi è
svolto dalla matematica, che è umanistica nei contenuti,
perché descrive e inventa mondi possibili, ma scientifica
nel metodo, perché usa la logica."
Curioso l'articolo "La rivincita dei fruttivendoli",
in cui si sottolinea come essi abbiano sempre disposto le arance
nelle cassette, o in mucchi al mercato, colmando a ogni srato
gli avvallamenti lasciati dallo strato precedente. Per quasi quattrocento
anni i matematici hanno provato a cercare disposizioni più
efficienti per le arance, senza trovarle. Tale problema, in realtà,
era stato posto nel 1611 da Sir Walter Raleigh, "il navigatore
al soldo della regina Elisabetta, che organizzò le spedizioni
da cui nacque l'imperialismo coloniale inglese: la sua preoccupazione
era trasportare nel modo più efficiente non arance, ma
palle di cannone. Il professor Thomas Hales dell'Università
del Michigan ha annunciato nell'estate del 1998 di aver finalmente
risolto questo famoso problema, grazie a una dimostrazione di
250 pagine e un programma di computer di 3 gigabytes: le arance
continueranno ad avere la stessa disposizione "in saecula
saeculorum", perché nessuno può fare di meglio.
Ovvero, anche la matematica deve inchinarsi alle leggi del mercato."
Nel saggio "Galline e teoremi" si parte dalla
famosa domanda "Viene prima l'uovo o la gallina?"
per giungere a citare Francis Crick, scopritore della struttura
del DNA (insieme con James Watson) e premio Nobel per la medicina,
nel 1962. È stato proprio F. Crick a formulare, nel 1957,
il cosiddetto "dogma centrale della biologia".
Come spiega nella sua autobiografia, egli usò la parola
"dogma" semanticamente intesa non come "verità
di fede", ma come "assunto fondamentale
che sta alla base della spiegazione molecolare dei meccanismi
darwiniani dell'evoluzione." Tale dogma centrale della
biologia afferma che "si va dall'informazione contenuta
negli acidi nucleici (DNA e RNA) e nelle sequenze di aminoacidi
alle proteine, ma non viceversa (gli acidi nucleici stanno alle
proteine come i nucleotidi A, T, C e G stanno agli aminoacidi,
e come il software sta all'hardware). In particolare, non si può
creare un organismo senza avere prima la sua informazione genetica,
e quindi l'uovo viene prima della gallina."
Essendo amante della precisione, Odifreddi si scaglia, infine,
contro un uso (o meglio, "abuso") improprio di determinate
parole; infatti, non molto tempo fa, vari uomini politici, ricevendo
avvisi di garanzia, sostenevano che i giudici avevano contro di
loro un "teorema", non tenendo in considerazione
che tale parola significa "affermazione provata".
Probabilmente intendevano solo insinuare che le argomentazioni
dei giudici erano cervellotiche e contrarie alla verità,
ma l'autore li richiama a un rigore linguistico necessario, per
cercare di impedire gli abusi a sfondo scientifico.
Odifreddi ha il merito di saper esporre in modo semplice e chiaro
concetti complicati, usando, nella sua opera divulgativa, una
simpatica e divertente ironia senza mai scivolare nella banalità.
|